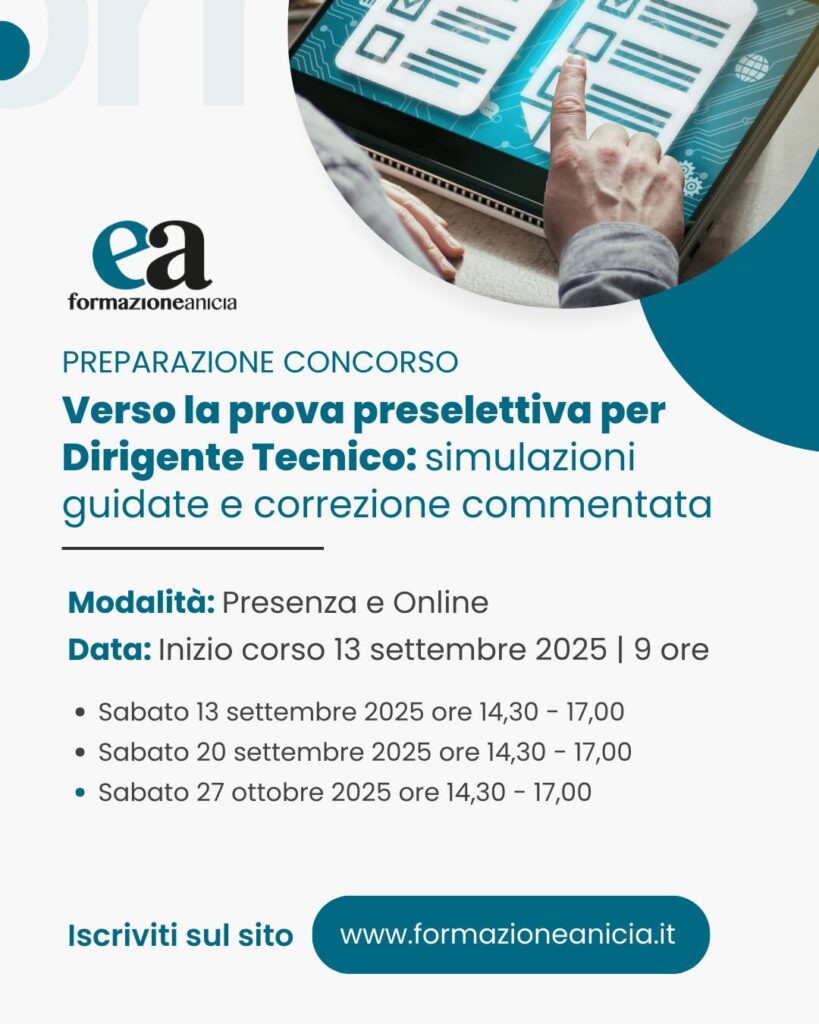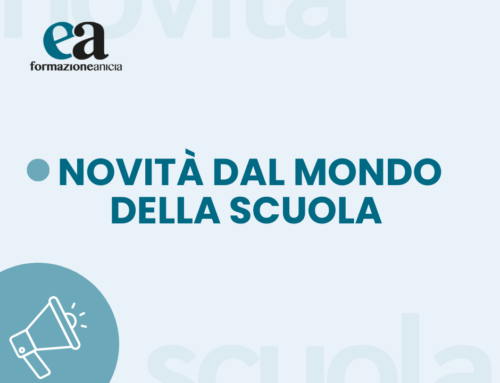Valditara: «Vi racconto come la scuola può diventare antidoto all’odio»
di , Avvenire
Il ministro fa il punto delle riforme al via con il nuovo anno scolastico. Che dovrà essere caratterizzato da «rispetto, responsabilità e gentilezza»
«Riportiamo al centro della società il rispetto e la gentilezza, a partire dalle scuole. Che possono essere il grande antidoto nei confronti della violenza, dell’odio, della maldicenza e della prevaricazione che spesso vengono alimentati dai social». All’alba del nuovo anno scolastico, prima ancora di parlare della nuova Maturità, del voto in condotta, del divieto di smartphone e delle altre novità che attendono gli studenti al ritorno tra i banchi, il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, vuole porre l’accento sul valore aggiunto rappresentato dalla scuola, in un momento in cui violenza, volgarità e prepotenza riaffiorano in diversi ambiti della società.
Ministro, a questo proposito, un tema che sta facendo molto discutere è la riforma del voto in condotta: quali sono le aspettative rispetto a questa riforma?
Il voto in condotta non serve tanto per reprimere quanto per educare, per richiamare alla responsabilità individuale, un valore che è stato accantonato nella società e che invece è tempo di riscoprire e rivivere. Parliamo di quello che è uno dei più grandi portati, insieme all’amore universale e alla carità, del Cristianesimo. Che fa della responsabilità individuale il perno di tutto il messaggio di Cristo. Senza responsabilità individuale il Cristianesimo non avrebbe la portata che effettivamente ha. Amore e responsabilità: questo è un grande lascito alla società occidentale.
L’anno scolastico si apre con la novità del divieto di smartphone a scuola, che ha animato il dibattito estivo. Nelle stesse settimane, il ministero ha varato le Linee guida per introdurre l’Intelligenza artificiale a scuola. Come si raggiunge questo traguardo senza telefonini?
Gli studi Ocse e anche quelli dell’Istituto superiore di Sanità dicono che gli apprendimenti attraverso smartphone sono peggiori rispetto agli apprendimenti tradizionali. Se uno strumento peggiora la didattica e i suoi risultati allora non è un buono strumento. Francamente mi stupiscono certe critiche e certe osservazioni. Ciò non significa che lo smartphone non possa essere utilizzato per bisogni speciali, per alcune forme di disabilità. E noi abbiamo salvaguardato queste situazioni. In linea generale lo smartphone a scopi didattici non solo peggiora gli apprendimenti, ma è di evidenza scientifica che il suo abuso porta a perdita di memoria, di concentrazione, perdita di creatività, arrivando a generare dipendenza. E anche qui tutti gli studi internazionali dimostrano che la dipendenza da cellulare è una nuova forma di dipendenza che si va ad aggiungere a quelle tradizionali. Noi vogliamo creare le condizioni perché il giovane possa crescere in modo sano, perché sia responsabile, autonomo, maturo, ed è dunque doveroso contrastare ogni forma di dipendenza. Quindi, che il ragazzo impari anche a stare lontano dal cellulare, credo che faccia solo bene. Un fatto che è di buon senso tanto che il divieto di smartphone a scuola ha registrato un gradimento dell’opinione pubblica che sfiora l’80%, fra i giovani arriva a quasi il 60%.
Come si combina, dunque, questa misura con l’utilizzo delle nuove tecnologie per la didattica?
Già nelle linee guida sull’Educazione civica di settembre 2024, abbiamo inserito l’uso corretto delle nuove tecnologie come veri e propri obiettivi di apprendimento. Dunque l’uso corretto degli strumenti digitali, compreso lo smartphone e l’utilizzo dell’Intelligenza artificiale. Abbiamo investito 2,1 miliardi di euro per la digitalizzazione delle scuole, con la dotazione di lavagne elettroniche, tablet e computer. Nel 2021-2022 avevamo un device ogni sei studenti, quest’anno scolastico si apre con quasi un device ogni due studenti. È evidente che la decisione di vietare lo smartphone, che vede sempre più Paesi seguire il nostro esempio – e che abbiamo anche promosso in Europa raccogliendo l’adesione di una dozzina di Nazioni – sta a dimostrare che siamo sulla strada giusta e che questa decisione è assolutamente necessaria. Al tempo stesso, siamo tra i primi Paesi a sperimentare l’uso dell’IA a supporto dei docenti per personalizzare la didattica e creare una scuola sempre più a misura di studente. Come si vede, stiamo sostenendo e implementando l’innovazione nella didattica, ma al tempo stesso teniamo alta la guardia su quanto invece può danneggiare i nostri ragazzi.
Novità importanti riguardano anche l’esame di Maturità, soprattutto all’orale: non c’è il rischio che, conoscendo le quattro materie a gennaio, i ragazzi abbandonino le altre?
Assolutamente no. Non dimentichiamo che c’è uno scrutinio di ammissione all’esame che, tra l’altro, boccia dodici volte di più dell’esame di Maturità. Quindi, due insufficienze determinano automaticamente la non ammissione all’esame, senza possibilità che il Consiglio di classe decida altrimenti. Mentre con una insufficienza, il Consiglio può decidere per la non ammissione. A questo proposito, racconto un caso personale, un esempio da non seguire.
Dica…
Non essendo uscita Matematica tra le materie dell’esame orale di quell’anno, da febbraio smisi di studiare Geometria. Salvo poi dover recuperare tutto in quindici giorni, per superare l’interrogazione decisiva per l’ammissione alla Maturità. Questo per dire che un buon insegnante sa perfettamente quello che deve fare in questi casi. Contiamo sulla maturità dei giovani e sul fatto che strumenti per sanzionare comportamenti immaturi ci sono. E questo sarebbe un classico comportamento immaturo che verrebbe considerato molto negativamente ai fini della valutazione finale. Ecco perché, tra l’altro, abbiamo inteso tornare al termine “Maturità” che un po’ ideologicamente era stato modificato nell’algido Esame di Stato. Perché vogliamo valorizzare la persona dello studente a 360 gradi. Come, d’altro canto, chiedono anche gli studenti. E cioè, non soltanto competenze e conoscenze, perché lo studente non deve soltanto conoscere i logaritmi: la sua persona è molto di più. E quindi valutiamo anche quel grado di maturità, di autonomia, di responsabilità che ha saputo raggiungere. Non a caso prevediamo di considerare anche gli impegni esterni, in qualche modo collegati con il percorso scolastico (per esempio, attività sportive e culturali), e abbiamo inserito la valutazione di azioni particolarmente meritevoli, che declineeremo con esemplificazioni molto concrete. Si tratta di misure utili a far capire il livello di maturità e responsabilità del giovane.
L’Ocse ci ricorda che gli insegnanti italiani sono tra i meno pagati. Così, però, è difficile rendere appetibile la professione e attirare i migliori laureati: cosa c’è sul tavolo in vista del rinnovo del contratto?
L’Ocse fa riferimento a un decennio in cui c’è stato il blocco dei contratti. Mentre negli altri Paesi i contratti venivano rinnovati e il potere d’acquisto aumentava, in Italia è addirittura sceso. L’ultimo contratto è stato firmato nel 2007/2009 e abbiamo dovuto aspettare una sentenza della Corte Costituzionale che ha costretto nel 2018 il governo dell’epoca a porre termine al blocco dei salari. Poi c’è stato uno stallo per tre anni nelle trattative e siamo dovuti intervenire noi nel novembre del 2022 con un primo, importante accordo economico. Quindi, l’Ocse ha fotografato un periodo drammatico della storia della scuola italiana che ha visto perdere in modo sensibile e significativo il potere d’acquisto dei salari dei docenti. Invece, dopo tre settimane dal nostro insediamento abbiamo chiuso un contratto che era aperto da tre anni. E per la prima volta nella storia della scuola italiana abbiamo poi previsto in anticipo le risorse per tutti i contratti fino al 2028-2030, così da assicurare quella continuità che prima non c’era. Dobbiamo adesso incrementare ulteriormente le risorse per il contratto 2025-2027. Ricordo inoltre che abbiamo appena stanziato ulteriori 240 milioni di euro una tantum che andranno sul contratto che è in fase di rinnovo in queste settimane proprio come riconoscimento del grande lavoro che svolge il personale scolastico.
Ministro, in questi giorni di ripresa delle lezioni, qual è, allora, il suo augurio per insegnanti, presidi, personale, studenti e famiglie?
Che la scuola sia un grande luogo di dialogo, di crescita in un contesto sereno finalizzato a valorizzare i talenti di ogni giovane. Questo è lo scopo della scuola che ho in mente, della scuola costituzionale: mettere al centro lo studente, individuare e valorizzarne i talenti, saper orientare i giovani a fare le scelte di studio e, in prospettiva, professionali che gli consentano di realizzarsi. La scuola è una grande comunità educante, dove il sorriso, l’accoglienza e il rispetto siano sempre presenti. Un termine, quello di rispetto, per me fondamentale, che ho messo nelle nuove Linee guida sulla Educazione civica e anche nei nuovi programmi scolastici. La centralità del rispetto: verso l’altro, verso la donna, verso l’insegnante, verso lo studente, verso i beni pubblici. Il rispetto è la cifra di una società veramente democratica.