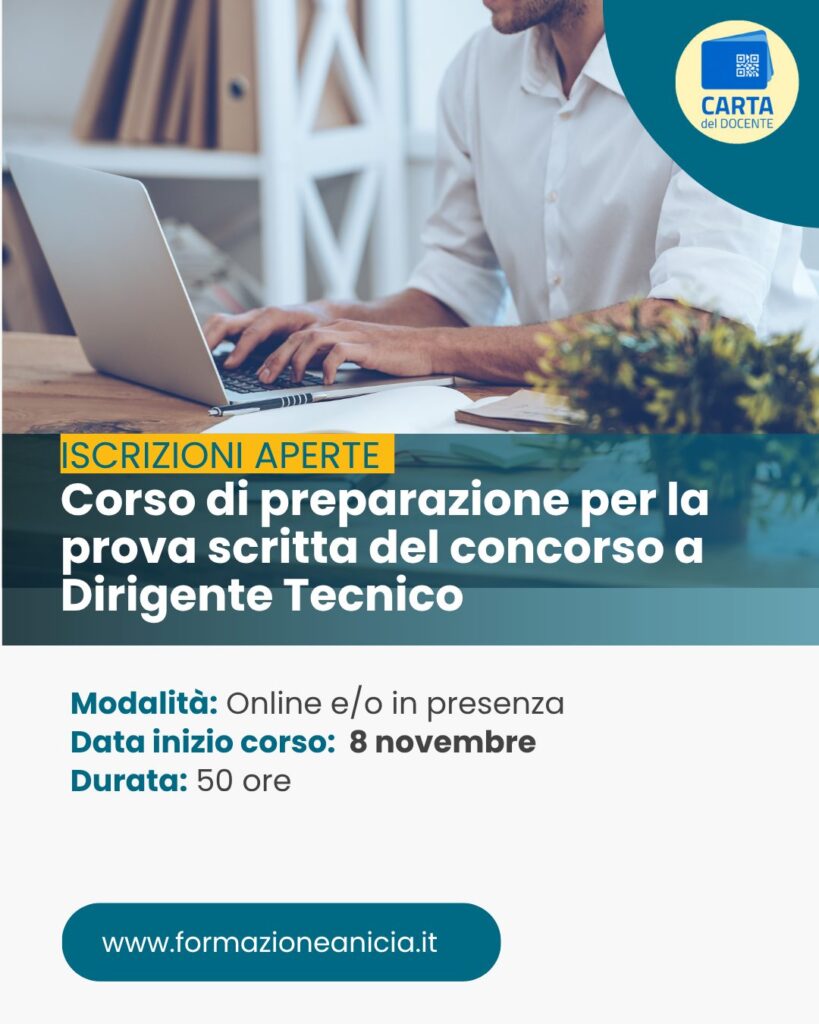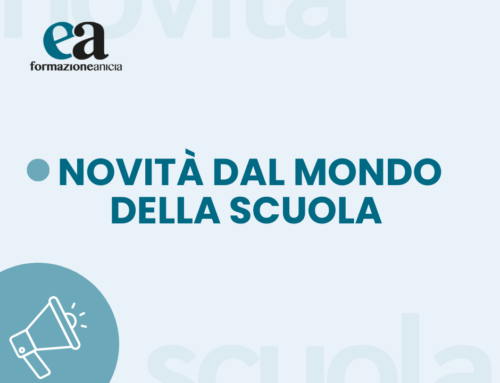Scuola, ricorsi al TAR, aggressioni fisiche, burnout
di Orizzonte Scuola
Le ricadute che la perdita del potere istituzionale degli insegnanti.
Non smantellate le sale docenti, è un luogo di sublimazione. Intervista a Gaetano Cotena.
Ci sono scuole che smantellano le sale professori per farne aule per gli studenti, senza rendersi conto che la sala professori è un luogo in cui i docenti si parlano, canalizzano e sublimano le loro fatiche verso un genitore o verso un alunno condividendole con i colleghi”.
E ancora: “Ricorsi al tar, aggressioni fisiche, burnout e svalutazione della funzione docente. Quali sono le ricadute che la perdita del potere istituzionale e del riconoscimento sociale dell’insegnante stanno avendo nel mondo della scuola e sull’educazione?” Sono riflessioni e domande che si pone e alle quali cerca di dare una risposta Gaetano Cotena, psicoterapeuta e docente di scienze umane che da molti anni eroga formazione emotiva e relazionale per gli insegnanti di ogni ordine e grado di scuola. “Sono passati più di cent’anni da quando, giustamente, pedagogisti e psicologi hanno messo al centro i bisogni del bambino e dell’adolescente – insiste Cotena – Nel frattempo, in questi cento anni, abbiamo perso di vista l’adulto, dimenticando che non può esserci una buona educazione se non c’è un adulto in buona salute psicologica, capace di rappresentare un riferimento e un modello nella gestione dell’emotività del bambino o dell’adolescente. Abbiamo dimenticato che quello che l’adulto fa, come sta l’adulto, è fondamentale per garantire al bambino e all’adolescente una buona esperienza relazionale, che è la base su cui si costruisce la capacità del futuro adulto di stare in relazione, di rispettare l’altro e di gestire la propria emotività”. Gaetano Cotena ha pubblicato recentemente il libro “Il docente al centro” (UTET Università 2025) che richiama l’attenzione sulla necessità di rimettere al centro la figura dell’adulto e che sarà presentato on line e in presenza in un evento organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Lombardia il 2 dicembre alle ore 21,che sarà possibile seguire anche on line iscrivendosi compilando l’apposito modulo.
Professor Gaetano Cotena, proviamo a partire dalla stringente attualità. Mai come in questo periodo alla scuola e ai suoi insegnanti viene chiesto di farsi carco della necessità di educare i giovani all’affettività, al rispetto degli altri, e di impartire, tra tante perplessità anche di provenienza istituzionale l’educazione sessuale. Qual è la sua opinione su questo fronte?
Alla scuola viene chiesto anche di educare alle relazioni e mi sembra che negli ultimi anni in effetti la richiesta sia chiaramente questa. E tuttavia dopo l’omicidio di Giulia Cecchettin c’era stata una nota ministeriale che invitava le scuole ad attivare percorsi di educazione alle relazioni. Poi non se n’è saputo più nulla. Questo fatto io lo metto spesso al centro della mia relazione alla didattica. Quello che si può dire è che a seguito di quel fatto gli investimenti nella formazione sono stati soprattutto se non quasi esclusivamente sul digitale e questa è una cosa oggettiva: a fronte di quella nota i soldi sono stati allocati sul digitale, cioè su come si fa un podcast e cose di questo genere. Se vogliamo educare alle relazioni, e se la scuola vuole fare davvero ciò, dobbiamo prendere il carico investendo su queste tematiche, invece non mi sembra che la scuola si stia occupando di ciò. Se la scuola deve educare alle relazioni allora trovo coerente inserire all’interno del percorso scolastico un percorso sessuo-affettivo dove per affettività intendiamo la capacità di regolare l’emotività: si tratta quindi di qualcosa che non riguarda solo l’incontro tra i corpi ma le relazioni tra le persone.
Come giudica il fatto che varie forze politiche pretendano di condizionare taluni interventi educativi al consenso della famiglia?
Mi sembra che uno dei più grandi problemi che stiamo affrontando oggi riguardo ai bambini e agli adolescenti sia proprio la difficoltà di un incontro autentico, nutriente, non aggressivo, non svalutante tra le persone. Mi sembra anche che l’emergenza sia un’emergenza relazionale tra questi ragazzi e quindi secondo me questo tipo di processo sarebbe da inserire anche senza il consenso dei genitori, se davvero vogliamo dare questa responsabilità alla scuola e cioè quella di educare all’affettività e alle relazioni. Dunque io dico no al consenso dei genitori, e dico invece sì alla scuola che diventa un posto in cui si formano i docenti ma anche i genitori.
In che senso?
Ci sono molte scuole che mi richiedono interventi non solo per gli insegnanti ma anche per i genitori e credo che questo sia un modo interessante per affrontare la questione perché è l’occasione per me di ribadire ai genitori che una reazione-aggressione nei confronti di un docente modula l’aggressività del figlio. Chiediamoci perché l’adulto è importante per l’educazione. C’è una domanda che faccio spesso ai docenti e ai genitori e cioè: che adulto sei? Perché un bambino o un’adolescente che guardano un adulto per la prima volta si chiedono sempre che adulto è quello che mi trovo di fronte in questo momento? A questo proposito però ci possiamo domandare anche quale sia il modello di adulto che stiamo proponendo.
Qual è?
Oggi una persona non diventa famosa perché ha scritto un buon libro e ha per questo la fortuna che una casa editrice lo legga – e sarebbe una bella cosa – ma chi ha visibilità e followers: peraltro è solo alla luce di questo che spesso gli viene pubblicato un libro. Oggi quindi se vieni seguito sui social ti si aprono tante porte poiché hai tanti followers. Il messaggio che gli adulti e la società stanno dando in generale ai bambini e ai ragazzi, e che rinforza questo processo, è che avere followers ripaga.
Questo che cosa comporta per un adolescente?
Il cervello degli adolescenti non fa differenza tra scrivere un libro, o fare una cosa intelligente, e andare su un grattacielo a farsi una foto oppure picchiare un coetaneo per pubblicare e soddisfare i propri bisogni di visibilità e di appartenenza. Il bisogno di appartenenza e di sicurezza i ragazzi di oggi lo soddisfano con l’appartenere al branco e quello di visibilità pubblicando sui social quello che fanno. E loro, cioè chi investe il proprio tempo nel farsi pubblicità con i social, sono i loro maestri: molti non sono diventati famosi dopo che hanno scritto un libro, tanto per tornare all’esempio, ma hanno scritto il libro dopo che sono diventati famosi sui social. È una legge di mercato per le case editrici, però dobbiamo stare attenti alle conseguenze di questi meccanismi poiché l’esempio che stiamo dando è che puntare in alto significa anche raggiungere una grande visibilità ma puntare in alto non è questo.
Veniamo alla violenza di genere e al ruolo della scuola e degli insegnanti nella prevenzione contrasto di questo tipo di comportamenti antisociali. Ce la fanno?
Sui docenti ricade spesso l’onere degli sportelli. Io mi ritrovo spesso in scuole in cui gli sportelli anti violenza e antibullismo sono gestiti da docenti ma credo sia necessario che ci siano dei professionisti formati su queste tematiche in generale, sento un proliferare di progetti nella scuola e questo per me è l’indicatore che non si sa bene che strada prendere. Da un lato parliamo di rendere la scuola un luogo di prevenzione e di benessere ma lo sportello psicologico nelle scuole non è diventato ancora strutturale. E questo per me è un paradosso, lo stesso paradosso che riscontro sulla formazione degli insegnanti, dove c’è uno scollamento tra quello che viene richiesto loro di fare, cioè educare al rispetto dell’altro e alle relazioni: è un sistema di formazione a cominciare da quella universitaria che non dota i docenti di strumenti concreti adeguati rispetto a quel che viene richiesto loro. È paradossale anche che fare formazione agli insegnanti sulle relazioni siano docenti universitari di pedagogia e psicologia che oltre alle teorie e alle ricerche che hanno condotto non hanno esperienza di relazioni. Spesso nei corsi di aggiornamento per i docenti sento ancora le solite teorie come quelle del Cane di Pavlov, che ormai conoscono tutti ma penso che il docente e la complessità di una classe abbiano bisogno di una formazione concreta, utile non solo agli alunni ma che sia utile anche a prevenire lo stress del docente. Quello che si è perso è l’investimento sull’adulto…
La fermo: a quale tipo di formazione allude?
Una formazione che risponde ad alcune domande concrete che mi pongono tutti gli insegnanti di tutti gli ordini e gradi di scuola: come stare con l’iperattivazione, con l’ansia degli alunni, con l’aggressività, con le diverse sfumature anche sintomatologiche che ci troviamo in classe ogni giorno, con l’isolamento, con i disturbi del comportamento alimentare, con gli attacchi di panico, con l’autolesionismo. Con le depressioni. Io penso che non si sia ancora affrontato seriamente questo tema e che queste domande restino ancora scoperte, perché affrontarle seriamente significa fare tre cose per me: significa intanto non limitarsi a dire ai docenti cos’è quella problematica sintomatologia, ma significa raccontare ai docenti altre due cose di cui non c’è traccia nell’attuale formazione. Queste due cose riguardano gli aspetti intrapsichici di quella problematica relazionale o comportamentale: per esempio qual è il mondo interno, cioè cosa sente un ragazzo ADHD, un timido, una persona isolata, una che soffre di disturbi alimentari o di depressione? Quante volte ci viene detto che dobbiamo essere empatici e che dobbiamo essere docenti comprensivi? Ma per essere empatici e comprensivi occorre che qualcuno spieghi il mondo interno di chi soffre di una sintomatologia, perché il sintomo psicologico tende a mantenersi anche allontanando gli altri, anche provocando gli altri poiché la sintomatologia tira dentro le persone che hai intorno.
Ci aiuti a capire meglio
Chi soffre di una problematica psicologica, per mantenere il sintomo tira dentro le persone che ha intorno. E perché li tira dentro? Perché struttura il sintomo come reazione a vissuti dolorosi o a un clima familiare disfunzionale: il sintomo si struttura sulla base dei vissuti, la persona fa fatica perché la sintomatologia protegge il soggetto dalla sofferenza legata a un vissuto, a un evento, a un clima disfunzionale. La persona depressa per esempio mantiene il sintomo lamentandosi spesso o utilizzando male la rabbia ed è chiaro che utilizzando male la rabbia e lamentandosi tanto alimenterà la propria solitudine. C’è bisogno di professionisti capaci di formare i docenti su questo aspetto e cioè nel favorire la conoscenza degli aspetti intrapsichici di alcune sintomatologie che i docenti spesso si ritrovano in classe. Questo per favorire la possibilità di empatizzare, non per curare poiché io credo molto nella distinzione chiara tra l’educazione e la cura, tra lo stare e il curare. Ma se mi viene chiesto di educare alle relazioni mi viene anche richiesto come docente di stare con tutte le sfumature emotive, sintomatologie comprese, e questo stare richiede un terzo aspetto della questione, che investe la formazione dei docenti, un aspetto chiamato in causa da Freud più di cent’anni fa, ed è l’aspetto del controtransfert, cioè della consapevolezza che il docente deve avere rispetto a quello che quell’alunno o quell’alunna sta provocando dentro di lui. Questo per evitare agiti e svalutazioni da parte del docente che talvolta rischiano di non essere funzionali all’educazione. Questi tre aspetti rappresentano gli strumenti che è necessario dare ai docenti in primo luogo per porsi come esempio di come si deve stare in relazione e in secondo luogo per prevenire il burnout dell’insegnante.
Lei sostiene che si è perso l’investimento sull’adulto.
Sono passati più di cent’anni da quando, giustamente, pedagogisti e psicologi hanno messo al centro i bisogni del bambino e dell’adolescente. Nel frattempo, in questi cento anni, abbiamo perso di vista l’adulto, dimenticando che non può esserci una buona educazione se non c’è un adulto in buona salute psicologica, capace di rappresentare un riferimento e un modello nella gestione dell’emotività del bambino o dell’adolescente. Abbiamo dimenticato che quello che l’adulto fa, come sta l’adulto, è fondamentale per garantire al bambino e all’adolescente una buona esperienza relazionale, che è la base su cui si costruisce la capacità del futuro adulto di stare in relazione, di rispettare l’altro e di gestire la propria emotività.
Lei dice pure che educare non è tirar fuori, come invece si ripete sempre. Che cosa intende con questa sua affermazione?
L’educazione non è solo un tirare fuori, come spesso viene raccontato ai docenti durante i corsi di formazione. Educare è soprattutto un mettere dentro attraverso due processi psicologici fondamentali che sono l’identificazione e l’introiezione. Dalle figure significative della nostra infanzia e della nostra adolescenza – genitori prima, e docenti poi – prendiamo atteggiamenti, comportamenti e reazioni emotive in situazioni di stress. Il bambino e l’adolescente si identificano e fanno propri gli schemi di reazione dell’adulto. È un fatto biologico e neuronale, che ha reso possibile la sopravvivenza della specie, permettendo ai più piccoli di acquisire molto presto le strategie di sopravvivenza. Questa è l’identificazione, che è un processo che dura tutta la vita.L’introiezione è mettere dentro le voci, i dialoghi che abbiamo fatto con le persone significative per noi. Sono le parole amorevoli che difronte ad un nostro errore ci hanno detto che avremmo avuto un’altra possibilità, oppure sono quelle che ci hanno messo con le spalle al muro, che ci hanno detto che eravamo incapaci o stupidi. Sono le voci eterne che restano dentro di noi e che spesso sono lo sfondo del benessere o del malessere emotivo. È necessario rimettere l’adulto al centro, iniziando dalla famiglia e dalla scuola. Da un lato, formare le famiglie a stare in questa complessità, spiegando che aggredire un docente o scrivergli una mail aggressiva dopo una nota o un voto inaspettato significa dare al figlio un cattivo esempio di adulto.
Prima ha detto che a scuola ci sono troppi progetti
Spesso è così. A scuola ci sono troppi progetti, troppe attività, che in nome della complessità stanno facendo perdere di vista non solo i reali bisogni degli alunni, ma soprattutto che un adulto senza strumenti per gestire la complessità emotiva in classe e schiacciato dalla burocrazia, può affidarsi solo alla propria umanità e alle proprie risorse interne per porsi come adulto stabile di riferimento e assolvere alla sua funzione.
Da cosa si evince quella che lei chiama perdita di potere istituzionale dei docenti?
“I ricorsi al Tar e l’invasione delle famiglie tolgono potere istituzionale e riconoscimento sociale; ma la svalutazione del docente, seppur sullo sfondo ci siano buone intenzioni, spesso arriva dalle scuole stesse. Ci sono scuole che smantellano le sale professori per farne aule per gli studenti, senza rendersi conto che la sala professori è un luogo in cui i docenti si parlano, canalizzano e sublimano le loro fatiche verso un genitore o verso un alunno condividendole con i colleghi. Ci sono scuole che non rispettano il piano delle attività, che è lo strumento principe che permette ad un docente di organizzare la propria vita personale e di prevenire lo stress. Ci sono scuole, che rendono i docenti burocrati subissati di documenti che fanno perdere di vista la funzione educativa, che si costruisce nelle ore in classe.
Torniamo alla formazione, su cui insiste tanto nel suo libro.
Non può esserci un adulto capace di stare con questa complessità senza mettere al centro della scuola e del processo di formazione i bisogni degli insegnanti. E il bisogno di formazione degli insegnanti non è solo sul digitale, su cui si sono concentrati gli investimenti di questi ultimi anni. Il docente ha bisogno di sapere come stare con la complessità di ogni giorno, come stare con l’ansia, la paura, l’aggressività, come proteggere sé stesso dall’invasione dei genitori. E i docenti hanno bisogno di uno spazio nel quale poter parlare delle relazioni educative faticose, di cui spesso finiscono per parlare nei consigli di classe, tra di loro, facendolo diventare uno spazio legittimo di lamentela e di condivisione, che andrebbe però accompagnato dalla presenza di supervisori esperti di relazione.
Strumenti questi, che non solo favorirebbero la prevenzione del burnout degli insegnanti, ma che coglierebbero esattamente quello che l’educazione chiede: porre difronte al bambino e all’adolescente un adulto in buona salute psicologica, che lavora in sicurezza e dentro soglie sostenibili di stress.
.