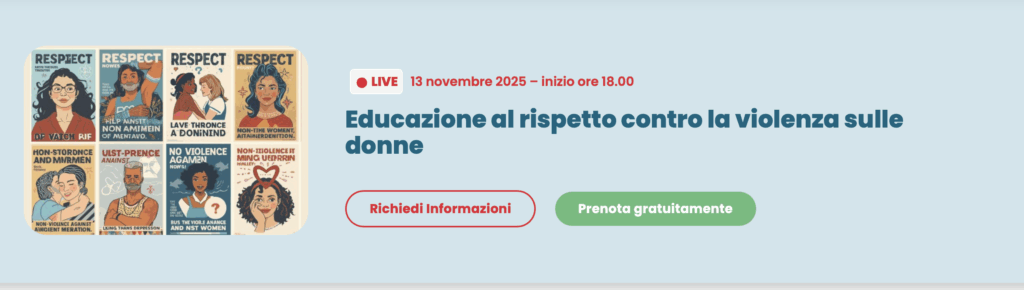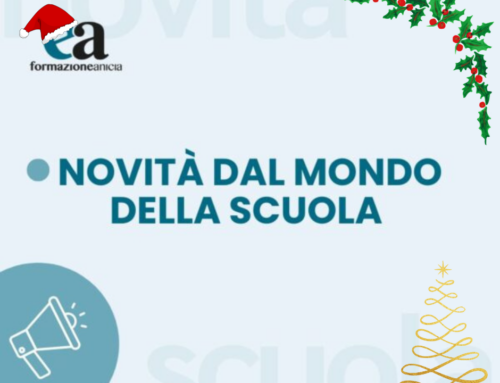Libertà di insegnamento: la legge tutela i gruppi minoritari
di Ferdinando Goglia, La Tecnica della scuola
La sentenza n. 6037/2025 della 2ª Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli RG 23503/2023.
La sentenza n. 6037/2025 della 2ª Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli RG 23503/2023, che mi riguarda personalmente, rappresenta un segnale importante per la scuola italiana. Essa infatti riconosce il diritto dell’insegnante, anche in forma individuale, ad avvalersi dell’opzione metodologica di gruppo minoritario di cui alla L. 107 art. 1 comma 14 punto 2, e sgombra così il campo da un pernicioso equivoco: nelle scelte didattico-pedagogiche, concernenti aspetti cruciali per la formazione culturale ed umana delle nuove generazioni, non vige quella che Toqueville chiamava la dittatura della maggioranza.
La libertà di insegnamento, cioè, non si declina soltanto a livello di istituto rispetto alle altre scuole, bensì anche all’interno di esse, come espressione delle legittime differenti prospettive ed esperienze di ciascun componente della comunità educante. In un quadro di conformità alle leggi, ai principi generali dell’istruzione e alla deontologia, nessuna maggioranza collegiale, a tutt’oggi, può imporre ad un docente di adottare teorie e pratiche didattiche in cui egli non crede.
Il contenzioso era scaturito da un presunto mancato adeguamento delle programmazioni didattiche da me presentate rispetto alla progettazione approvata a maggioranza in sede di Collegio dei docenti.
Il giudice sancisce in modo lapidario: “Avendo dunque legittimamente esercitato questa opzione minoritaria, il ricorrente ha operato nell’ambito della propria autonomia didattica, rispettando pienamente la normativa vigente e le prerogative degli Organi Collegiali. Giova qui ribadire che il principio di collegialità, applicabile nel caso specifico al Collegio dei Docenti, rappresenta un valore democratico fondamentale. Proprio per questo, la legge 107/2015, riguardo alle scelte didattiche, tutela i gruppi minoritari al comma 14. Di conseguenza, la sanzione imposta dal Dirigente Scolastico risulta del tutto priva di giustificazione e illegittima”.
Dall’esterno, ciò potrebbe sembrare quasi scontato, data la previsione costituzionale dell’art. 33. Ma non lo è. La fotografia attuale delle scuole italiane è un’altra: delibere adottate abitualmente all’unanimità, spesso senza accenno di dibattito, sulla scorta di quanto richiesto dai Dirigenti Scolastici, a loro volta sollecitati in certe precise direzioni da superiori livelli amministrativi.
Da quando, con l’Autonomia scolastica e il Sistema Nazionale di Valutazione, l’aziendalismo, col suo portato di verticalizzazione dei ruoli (INVALSI, Dirigente Scolastico, staff dirigenziale, figure strumentali, referenti di dipartimento, coordinatori di classe), ha iniziato a permeare la gestione della scuola, questa, oltre ad incarnare la filosofia neoliberale, è divenuta lo strumento elettivo deputato a veicolare pedagogicamente alle nuove generazioni, di quella filosofia, assunti e valori di fondo, attraverso una correlata didattica ed un correlato apparato docimologico.
Risulta evidente che la sopravvivenza della libertà nell’insegnamento/apprendimento e, con questa, dell’idea stessa di una scuola democratica che sia reale espressione e fucina della feconda complessità di una società plurale, stia nella possibilità di riaffermare in modo chiaro, in ogni istituto scolastico, che il pensare “divergente” è legittimo, che sia possibile e giusto prendere le distanze da quel dictatproduttivista che, attraverso discutibili richieste dall’alto, stravaganti circolari, corsi di formazione etc., ambisce a divenire pensiero unico.
L’opzione metodologica di gruppo minoritario, in questo senso, smaschera la natura retorica del tatcheriano There is no alternative, restituendo il dibattito all’interno dei Collegi dei docenti alla sua propria dimensione politica. Consente, ad esempio, di preferire che gli studenti si esercitino nell’organizzare ed esprimere conoscenze e giudizi attraverso forme quali colloqui e temi anziché cimentarsi con batterie di quesiti a risposta multipla. Di trattare la valutazione non alla stregua di una misurazione comparativa bensì quale stima approssimativa e fallibile che scaturisce dall’incontro tra due irripetibili ed uniche soggettività, quelle del docente e del discente. Di restituire priorità alle ordinarie attività curricolari rispetto al proliferare di proposte aggiuntive che, quand’anche valide, sembrano spesso non tenere conto che il carico quotidiano di impegno degli alunni è un prodotto a somma zero.
Lo strumento legislativo, dunque, c’è. E questa sentenza, a mio avviso preziosa, ce lo ricorda. La buona volontà e quel po’ di coraggio necessari per farne uso sta a ciascun docente attingerli, se vuole, alla propria coscienza civica e professionale.
.