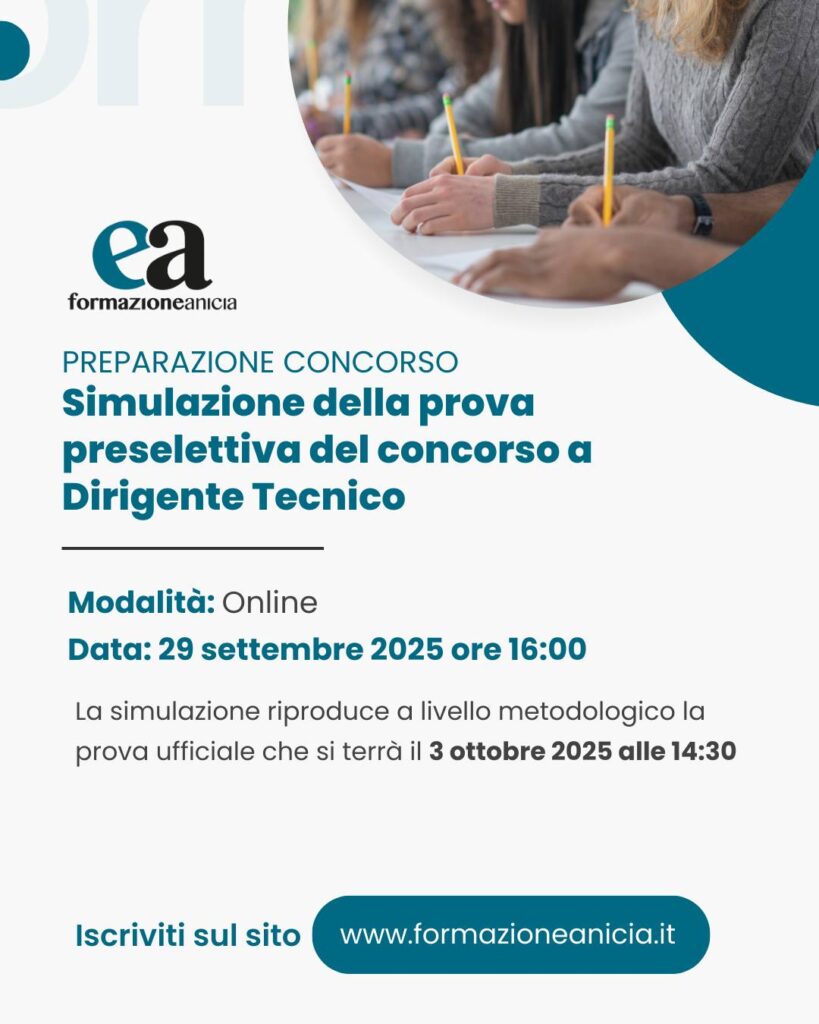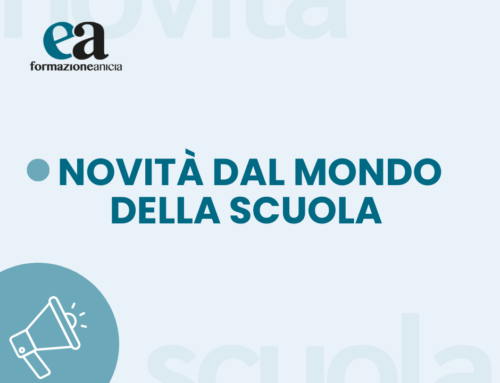La responsabilità erariale a scuola
di Tommaso Miele, Scuola7, n. 446 del 21.9.2024.
Personale docente e dirigenziale a confronto. Personale docente e dirigenziale a confronto. Danno erariale diretto ed indiretto confine tra Illecito disciplinare e responsabilità erariale.
La responsabilità del personale scolastico[1] ha molteplici declinazioni: civile, penale, disciplinare ed erariale. In particolare, la responsabilità erariale riveste una rilevanza cruciale per i docenti e i dirigenti scolastici, soggetti a un rapporto organico con l’Amministrazione statale. Capire i confini di questa responsabilità è essenziale per distinguere tra semplice illecito disciplinare e danno erariale, specialmente alla luce della recente giurisprudenza. Ricordiamo che la responsabilità erariale, nel contesto del diritto italiano, è una forma di responsabilità giuridica che riguarda coloro che, agendo per conto di un ente pubblico, causano un danno economico all’amministrazione stessa.
Responsabilità nella scuola statale
La scuola statale opera in equilibrio delicato tra esigenze formative, gestione oculata delle risorse e tutela di tutti coloro che ne fanno parte: studenti, personale e famiglie. In questo contesto le ipotesi di responsabilità del personale scolastico possono configurarsi come tema centrale, specialmente quando a seguito di azioni od omissioni del personale, si verifica un danno a carico dello Stato.
La responsabilità che può interessare il personale della scuola è principalmente quella amministrativa-contabile, che si configura quando un’azione o un’omissione provoca un danno all’Erario. La Corte dei conti è l’organo giurisdizionale che ha il compito di accertare tale danno e di agire per recuperare le somme dovute.
Quando questo danno risulta patrimoniale per l’Erario può agire in rivalsa, richiedendo il risarcimento a chi abbia agito con dolo (intenzione di danneggiare) o colpa grave (negligenza, imprudenza o imperizia di eccezionale gravità).
Danno erariale diretto ed indiretto
Il danno erariale può manifestarsi in due forme principali: danno erariale diretto ed indiretto.
- Il danno erariale diretto si verifica se l’azione illegittima comporta una spesa non dovuta per l’amministrazione (gestione impropria di fondi o materiali) o una mancata entrata. Facciamo alcuni esempi. Se un dirigente approva un acquisto di attrezzature superflue e costose senza una reale necessità didattica, ha fatto una gestione impropria di fondi e materiali, come pure se autorizza una missione di un dipendente con conseguenti rimborsi di spese non giustificate, o anche se rilascia false attestazioni che permettono ad una persona di ottenere un beneficio economico dallo Stato senza averne i requisiti.
- Il danno erariale indiretto si configura quando lo Stato (o un’altra amministrazione pubblica) si trova a risarcire un terzo (un alunno o i suoi genitori), a causa della condotta colpevole di un dipendente.
Un esempio è quando la scuola viene citata in giudizio e condannata a risarcire i genitori di un alunno che si è infortunato per mancata sorveglianza da parte di un docente. In questo caso, l’istituto risarcisce il danno (danno erariale indiretto) e la Corte dei conti può successivamente rivalersi sul docente responsabile. Si tratta sempre di danno indiretto quando un dipendente si infortuna a causa di una negligenza di un collega e lo Stato è costretto a pagare indennizzi o risarcimenti.
Caso di bullismo: responsabilità e prova liberatoria
Un esempio, purtroppo di grande attualità, riguarda il bullismo scolastico. Se a seguito di episodi di bullismo la vittima subisce un danno e la scuola viene condannata al risarcimento – perché non ha adottato adeguate misure di prevenzione, pur essendo a conoscenza della situazione – lo Stato potrebbe agire verso i singoli responsabili (docente e/o dirigente) per danno erariale indiretto in presenza di dolo o colpa grave.
L’omessa vigilanza da parte del personale scolastico, che risultata determinante per il danno subito da un alunno, fa scattare la responsabilità indiretta dell’Erario e, potenzialmente, una successiva azione di rivalsa verso i responsabili interni. Dirimente per l’istituzione scolastica è la “prova liberatoria”, ossia la scuola deve dimostrare di aver adottato tutte le cautele possibili, anche in presenza di un evento dannoso, mediante azioni mirate. Cosa include la prova liberatoria?
- Adozione di protocolli e regolamenti. La scuola deve dimostrare di aver adottato un regolamento d’istituto che disciplini chiaramente il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, con misure di prevenzione e sanzioni.
- Attività di prevenzione. L’istituto deve aver svolto attività educative e formative (es. laboratori, incontri con esperti) per sensibilizzare studenti, docenti e famiglie.
- Intervento tempestivo. Di fronte a una segnalazione, la scuola deve aver agito prontamente, adottando le misure previste (es. colloqui con gli studenti e le famiglie coinvolte, attivazione di un percorso di supporto psicologico).
- Circostanze imprevedibili. La scuola deve poter dimostrare che l’evento dannoso è stato del tutto imprevedibile e inevitabile, anche con una sorveglianza adeguata. Ad esempio, se l’episodio di violenza si è verificato in modo fulmineo e improvviso, in un contesto in cui la sorveglianza era regolarmente assicurata.
Responsabilità del personale docente: culpa in vigilando
Per il personale docente la responsabilità principale è la culpa in vigilando, cioè il dovere di sorvegliare gli alunni mentre sono loro affidati. La giurisprudenza richiede che i docenti esercitino costantemente un controllo idoneo a prevenire fatti dannosi imputabili a minori sotto custodia, sia durante l’insegnamento sia durante le pause ricreative. Il mancato rispetto di questi obblighi può portare a conseguenze civili (risarcimento al danneggiato), disciplinari (sanzioni interne) e, talvolta, erariali (quando lo Stato si sia trovato a dover risarcire terzi e agisca in rivalsa).
La responsabilità erariale è tuttavia subordinata alla presenza di dolo o colpa grave. Non è sufficiente, però, qualsiasi disattenzione o genericità nell’adempimento; è la gravità della condotta e il nesso con il danno subito dall’Erario a delimitare il campo del giudizio contabile. Questo principio è cruciale, poiché distingue il semplice errore umano, che può essere corretto in sede disciplinare o amministrativa, da una condotta che richiede un intervento giurisdizionale della Corte dei conti. Ricordiamo, comunque, che oltre al dolo o alla colpa grave, un altro elemento indispensabile per configurare la responsabilità erariale è il nesso di causalità tra la condotta del dipendente e il danno subito dall’Erario. Il danno deve essere una conseguenza direttaeimmediatadell’azione o omissione del dipendente. Se si dimostra che il danno si sarebbe comunque verificato, o se è stato causato da fattori esterni non controllabili dal dipendente, il nesso di causalità viene meno.
Funzione manageriale e culpa in organizzando
Diversa, ma complementare, la posizione del dirigente scolastico, la cui responsabilità è di tipo culpa in organizzando. Qui si valutano le scelte organizzative: pianificazione degli orari, allocazione delle risorse, predisposizione di protocolli per la sicurezza e il benessere degli alunni, formazione e informazione del personale.
Il dirigente è responsabile se, per omissione o negligenza nella strutturazione dell’apparato organizzativo, crea le condizioni che permettono o facilitano il verificarsi di eventi dannosi.
Nel caso di bullismo, anche il dirigente può essere chiamato in causa insieme al docente, specie se si dimostra che a monte delle singole omissioni vi sia stata una più ampia carenza organizzativa che ha permesso al bullismo di diffondersi.
Per esempio:
- non ha predisposto misure di prevenzione efficaci, come la promozione di progetti educativi contro il bullismo;
- non ha formato adeguatamente il personale docente e non-docente per riconoscere e gestire i casi di bullismo;
- non ha dato seguito a segnalazioni di bullismo da parte di studenti, genitori o personale scolastico, minimizzando o ignorando la gravità della situazione;
- non ha implementato protocolli chiari per la gestione delle emergenze e delle situazioni di rischio.
Tuttavia, anche qui, la responsabilità erariale richiede sempre il riscontro del dolo o della colpa grave.
Confine tra Illecito disciplinare e responsabilità erariale
Un passaggio fondamentale riguarda la distinzione tra illecito disciplinare ed erariale. Non tutte le condotte negligenti, infatti, danno luogo per responsabilità verso la Corte dei conti. Le sanzioni disciplinari coprono generalmente le violazioni degli obblighi di servizio che non si sono tradotte in danno economico per l’Erario o che sono frutto di errori non gravi.
La giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione e della Corte dei conti stabilisce che solo la presenza di dolo o colpa grave e l’effettivo pregiudizio economico per l’amministrazione consentono di configurare una responsabilità patrimoniale rivalsa.
Questa responsabilità si configura, quindi, quando un dipendente pubblico causa un danno all’amministrazione, e quest’ultima, dopo aver risarcito un terzo, si rivale sul dipendente per recuperare il danno subito.
È stato chiarito che questa responsabilità non scatta in automatico, ma richiede la contemporanea presenza di due elementi essenziali: quello soggettivo (dolo e colpa grave) e quello oggettivo (pregiudizio economico). Questo per evitare che i dipendenti, per paura di rischiare il proprio patrimonio per ogni errore, smettano di prendere decisioni o di agire con la necessaria celerità ed efficacia.
La colpa lieve (un errore di minore entità) non è sufficiente per avviare un’azione di rivalsa.
In sintesi
La crescente attenzione verso la responsabilità erariale nella scuola impone ai dirigenti e ai docenti una consapevolezza costante del proprio ruolo istituzionale e dei rischi giuridici connessi. Prassi virtuose di prevenzione – come l’aggiornamento dei protocolli, la formazione continua e l’attenta documentazione delle attività di vigilanza e organizzazione – rappresentano la prima tutela per i bambini e i ragazzi, ma anche uno scudo contro le più gravi forme di responsabilità contabile.
Solo nella consapevolezza e nel rispetto dei propri doveri, alla luce della distinzione tra illecito disciplinare ed erariale, il personale scolastico può operare serenamente, tutelando sia l’interesse pubblico sia la propria posizione personale.
.
[1] L’articolo costituisce una sintesi della relazione che Tommaso Miele – Presidente Sezione Giurisdizionale Corte dei Conti, Lazio – ha tenuto a Gaeta, durante la Start School che si è svolta nel periodo 21-23 luglio 2025.
.