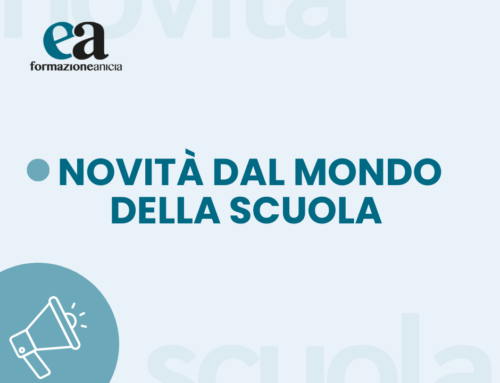Il lavoro di un prof non è (quasi) più insegnare
Burocrazia, report digitali, ricevimenti: a scuola il prof si trova a dover far fronte a una serie di incombenze, burocratiche e non, che lo allontana dal lavoro educativo.
18 ore: questo l’orario obbligatorio di lezione dei docenti della scuola secondaria (e 24 ore per gli insegnanti della primaria). Un orario di lavoro definito e corrispondente a quello che un tempo costituiva la “cattedra” delle materie letterarie (greco e latino compresi) dei docenti di una quarta o di una quinta ginnasio del liceo classico.
Intorno a questo magico numero orario, multiplo di tre e di sei, si è sviluppato il lavoro dei docenti in Italia, almeno nell’ultimo secolo. Un monte ore ambiguo e contrastato. Da una parte è innegabile che l’insegnamento è stato spesso considerato come un lavoro part time, adatto a madri di famiglia o a professionisti che dedicano il proprio tempo a un secondo lavoro (o, forse, al loro vero lavoro). Dall’altra questo ha permesso che a scuola vi fossero docenti che ripetevano stancamente per anni le proprie lezioni, senza che nulla cambiasse: poco veniva loro richiesto, poco davano.
Negli anni 90 ci fu qualche tentativo di ampliare e modificare gli orari di lavoro: alle 18 ore si aggiunse la possibilità di aggiungerne fino a 6. Possibilità che rimane oggi per coprire supplenze difficili da assegnare diversamente.
In filigrana questa possibilità faceva cogliere un duplice limite: quello della retribuzione e quello dell’effettivo tempo di lavoro. Infatti, dato che consente di ampliare di un terzo il proprio impegno lavorativo, la norma sembra lasciar intendere che un docente può lavorare di più.
Negli ultimi anni, però, la realtà dell’insegnamento si è modificata e richiede oggi tempi e competenze di livello professionale sempre maggiori. Alcune normative introdotte e un profondo cambiamento delle richieste della società nei confronti della scuola hanno costretto i docenti a un lavoro più vasto, più profondo, più complesso.
Ovviamente, come in altri ambiti lavorativi, c’è chi esercita il quiet quitting, approfittando in più delle pause delle vacanze scolastiche, ma le esigenze degli studenti, le richieste delle famiglie, gli obblighi normativi, la pressione delle nuove tecnologie rendono questo modo rinunciatario di affrontare la scuola sempre più difficile e limitativo, se non – talora e in certi ruoli – impossibile.
La maggior parte dei docenti si è trovata di fronte a tre cambiamenti che hanno trasformato la loro professione.
1.
Innanzi tutto la massiva formalizzazione delle procedure d’insegnamento: se trent’anni fa l’insegnamento si irrigidiva solo in pochi atti amministrativi, soprattutto in quelli finali, la crescente consapevolezza che si deve rendere conto di quanto è stato realizzato in classe, benché non sempre abbia migliorato le relazioni e favorito la trasparenza, ha certamente moltiplicato e complicato le carte, investendo un po’ tutti i momenti della scuola, dall’ingresso alla stesura del registro e alle uscite, fino ad arrivare alla correzione dei compiti e dei recuperi.
Non parliamo poi dei diversi progetti, soprattutto quelli in rete o che implicano la collaborazione di altri soggetti, nelle quali il rapporto va debitamente formalizzato per non correre rischi sulla vigilanza dei ragazzi o, addirittura, sulla sicurezza, per esempio nei percorsi di Alternanza scuola-lavoro.
Così le domande dei docenti ai dirigenti e le indicazioni che da questi ultimi si indirizzano ai primi sono sempre più spesso di natura formale e poco riguardano il contenuto e il metodo dei processi educativi, tanto meno le persone degli studenti.
2.
Una seconda spinta alla crescita del carico di lavoro è paradossalmente dovuta all’introduzione sempre più ampia di strumenti digitali che lo dovrebbero in linea teorica semplificare e snellire. In realtà le comunicazioni in chat e gli scambi di e-mail normalmente accrescono i pesi, rendono complesse le relazioni, creando fraintendimenti e facendo rifugiare in atteggiamenti direttivi o difensivi.
Il registro elettronico è onnipresente: l’appello, le entrate in seconda ora, le uscite anticipate, le valutazioni. Poi la consultazione delle circolari della scuola, e il deposito del materiale didattico. Tutte operazioni che richiedono tempo: sulla cattedra il tablet è costantemente acceso. Le verbalizzazioni e i report in formato digitale moltiplicano testi che si ha l’impressione che nessuno o quasi leggerà.
Talora addirittura accade che le procedure si irrigidiscano ulteriormente a causa delle macchine e che pratiche da sempre accettate e non normate vengano sottoposte a nuove rigide procedure, anche senza una base normativa reale, ma sempre in una logica difensiva e direttiva che si illude di “gestire” ingabbiando la realtà nelle caselle già previste.
3.
Una terza spinta deriva dalla differenziazione e dalla personalizzazione didattica legate, in particolare, agli alunni con Bisogni educativi speciali (BES), ma anche ad altre categorie, come gli studenti atleti che praticano sport a livello agonistico e hanno diritto a un piano formativo individualizzato. Se la personalizzazione appare una necessità pedagogica, questa non avviene a costo zero, ma richiede tempo e risorse, e – ricordiamolo – non NAI solo per applicare e documentare, ma anche per ideare, progettare, realizzare gli interventi, verificare, valutare e mettersi in relazione personale con l’allievo. E questo richiede una formalizzazione con documenti specifici che pianifichino gli interventi e siano condivisi: quindi necessitano tempi di progettazione e discussione collegiale.
Spesso le classi accolgono pure numerosi NAI (Nuovi arrivati in Italia): studenti stranieri che non parlano italiano o lo parlano poco, o che sono stati inseriti a scuola da meno di due anni. Questa sigla indica la necessità di un approccio didattico e di accoglienza specifico per facilitare il loro inserimento nel sistema scolastico italiano, fornendo supporto linguistico e strategie educative su misura.
Immaginiamoci poi se in classe entra addirittura un minore non accompagnato, con tutto il suo carico di sofferenza e di trauma! I tempi di lavoro e di preparazione si dilatano e diventano spesso non programmabili perché le circostanze possono richiedere continui interventi.
Di recente Repubblica ha dato spazio a una ricerca del CIDI (Centro democratico insegnanti) che ha esplorato “tutte le attività previste dall’attività di insegnamento nei due ambiti in cui si svolgono: a scuola e fuori dalla scuola”. La preparazione delle lezioni e delle attività didattiche, la compilazione del registro elettronico, la partecipazione alle riunioni degli organismi collegiali e delle commissioni, i ricevimenti e le comunicazioni, formali e informali, con i genitori e per collaborare con il dirigente scolastico o con il suo staff e seguire le comunicazioni che arrivano dalla dirigenza scolastica, in media, impegnano in media i docenti italiani per 13 ore aggiuntive settimanali alla primaria e 14 alla media e alle superiori. Ma spesso sono molte di più.
Eppure il problema più rilevante non consiste nella crescita delle ore di lavoro e nella loro concentrazione in alcuni periodi in particolare. L’aspetto più grave è che gli insegnanti vivono questo aumento di ore come ulteriore prova della loro insignificanza. Non riescono infatti a percepire come queste ore di lavoro che spendono per la scuola, per le classi, per gli alunni, riescano a portare davvero frutto, permettano di far crescere i ragazzi, rendano perciò il loro impegno davvero significativo. Il lavoro aumenta, le ore non bastano mai, ma l’educazione e l’istruzione, ciò che è insegnato e ciò che accade in classe e nella relazione tra adulto e ragazzo e tra i ragazzi resta alla fine in secondo piano, se non diventa addirittura un dato di fatto scontato.
C’è poco da fare: anche questo problema, se vuol trovare soluzioni, deve riguadagnare il centro e il senso di fare scuola, deve riporsi l’interrogativo sullo scopo dell’azione e dell’istituzione. Come ha scritto recentemente Nora Terzoli riprendendo Massimo Recalcati, “Gli insegnanti, come tutti gli educatori non sono semplicemente ‘rappresentanti della Legge’, ma portatori del ‘fuoco del desiderio’… Una scuola che educa deve allora investire sull’umanità dei suoi educatori, sostenendoli nella crescita personale e professionale, perché solo chi è vivo può generare vita.”
Concorso per Dirigente Tecnico – al via il corso per la prova scritta
|
|---|
|
|
|
|