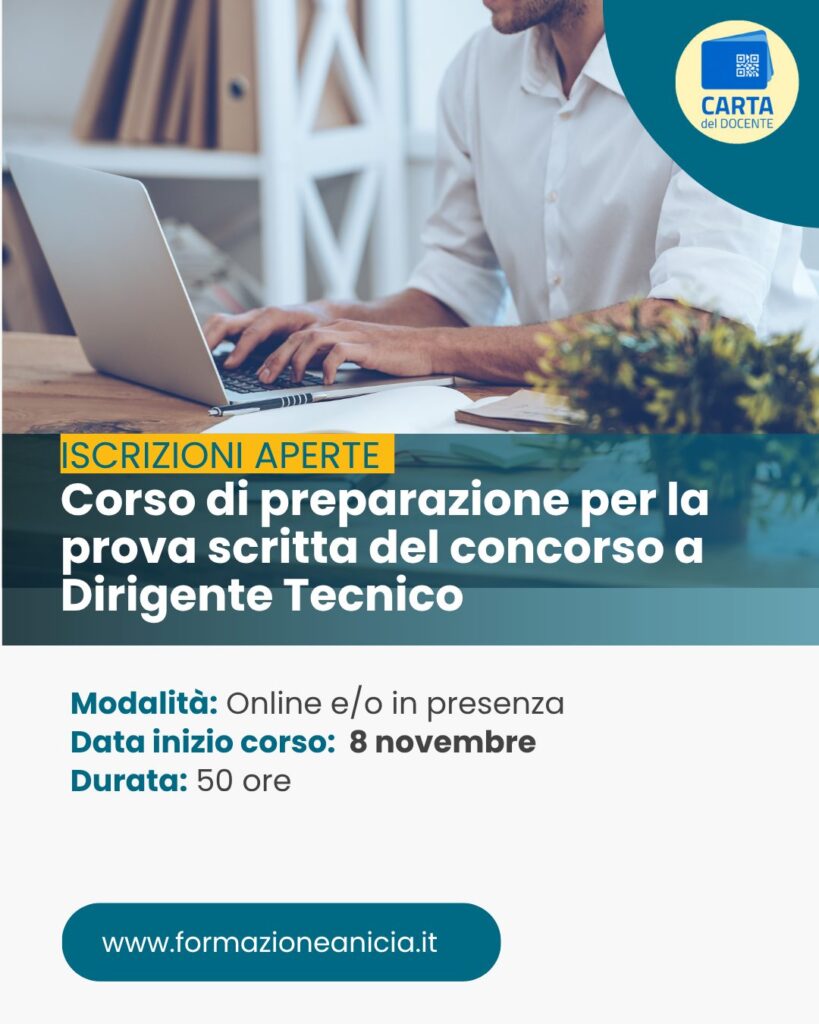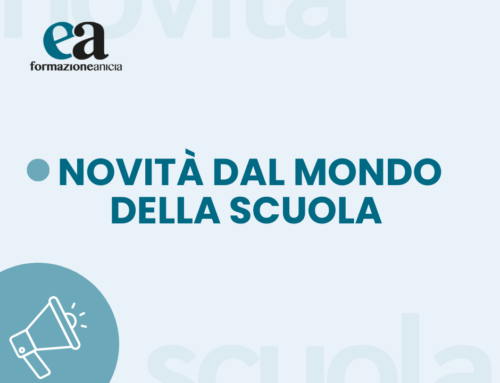Nelle classi più numerose si impara meglio
di Andrea Ceriani, La Tecnica della scuola
Lo dice anche il Ministro, esaltando gli investimenti fatti
e nascondendo le ‘sforbiciate’ inflitte alla scuola.
Non è stata del tutto opportuna la scelta, da parte del Ministero dell’Istruzione e del merito (in un intervento durante il Forum Welfare Italia), di difendere, anzi, esaltare le classi numerose, ritenendole più valide, per quanto riguarda i risultati, delle classi formate da un numero contenuto di alunni.
Tanto meno è apparsa vincente la mossa di affidarsi, per sostenere la sua tesi, ai dati INVALSI, sempre generali e sempre interpretabili in modo vario e perfino contrapposto, soprattutto se letti superficialmente o con l’obiettivo evidente di sostenere una ‘propria’ verità.
Non poche, quindi (e non senza ragione), sono state le critiche rivolte a questa decisa presa di posizione (mal ponderata e poco credibile) a favore dei ‘numeri grandi’. Invero non si può, in maniera scientifica, razionale e precisa, stabilire il numero esatto e maggiormente ‘prestazionale’ di alunni per classe. Troppi e troppo diversi sono gli elementi e i fattori da prendere in considerazione (come vari esperti ‘scolastici’ hanno fatto polemicamente notare), tanto diversi che, in alcune realtà (o addirittura nella stessa realtà) numeri grandi funzionano e numeri piccoli no; invece, in altri contesti, le ‘posizioni’ si invertono.
A grandi linee si potrebbe affermare, comunque, che, se si vuole operare bene, una classe non dovrebbe superare le 23 (massimo 24) persone, ma tutti sappiamo che, specialmente nelle medie o, ancor di più, nel biennio delle superiori, questo limite massimo viene spesso ampiamente superato. La difficoltà poi di ‘non ammettere’ un alunno non meritevole (difficoltà ogni anno sempre più grande e difficilmente superabile), porta ad avere numeri importanti, per classe, fino alla fine del percorso scolastico.
Ugualmente, sempre in generale, potremmo indicare un numero oscillante tra 16 e 20 come il numero ‘adeguato’ (non diciamo perfetto) per una classe. In questo modo un docente potrebbe seguire con attenzione ogni alunno, anche l’allievo o gli allievi ‘fragili’, e dedicargli il tempo e le cure necessarie per riuscire a farli crescere correttamente e a permettergli di trovare in loro stessi la forza per superare debolezze, dubbi e incertezze.
Probabilmente, operando in una classe ‘misurata’, un unico docente sarebbe in grado di conoscere meglio ogni singolo allievo e, se necessario, attivare percorsi di apprendimento differenti secondo le caratteristiche e le predisposizioni di ogni discente (chiamiamoli ‘piani personalizzati’). Sarebbe così sufficiente un solo insegnante (per materia) in classe senza la presenza di docenti di sostegno (se non nei casi di evidenti e vere ‘disabilità’). Al contrario, in classi numerose e eterogenee (soprattutto in questa fase storica della scuola, inflazionata e infittita da ‘infiniti’ numeri di ‘fragilità’, vere, presunte o esagerate), l’azione educatrice dell’insegnante di cattedra è supportata da non pochi colleghi di sostegno che aiutano gli alunni in ‘difficoltà’ a seguire la lezione, a svolgere i compiti e anche a prepararli per le interrogazioni (rigorosamente programmate e limitate ad argomenti scelti dagli alunni insieme ai loro insegnanti di sostegno). Se poi la situazione all’interno della classe diventa troppo caotica, accade spesso che i docenti di sostegno prendano i ‘loro’ alunni ‘deboli’ e li portino in un’altra aula per svolgere, seguendo le direttive del docente di cattedra, la lezione su una determinata materia. Si crea così, in tal modo (almeno per brevi spazi temporali), una specie di piccola classe ‘differenziata’.
Forse è proprio questa la soluzione migliore se dovessimo dare ascolto ad alcuni sondaggi qualificati dove emergerebbe il desiderio di non pochi professori di tornare a classi differenziate o parzialmente differenziate. Comunque sia (non intendiamo esporci troppo riguardo la necessità o meno di un ritorno al passato), la voce del Ministero è chiara: costituire classi ‘giganti’ e ‘riempirle’ di docenti di sostegno. Anzi, ancora meglio: trasformare i professori di sostegno in professori dell’inclusione attraverso, pensiamo noi, i soliti corsi on-line frettolosi, generici e lacunosi.
Su questo scommette il Ministero (altro che classi numericamente basse e ben gestibili!) e per questo ha investito tantissimo (dice lui) e intende, in futuro, investire ancora di più (i tagli alla scuola non sembrano esistere o, se esistono, derivano, naturalmente, dal calo demografico degli alunni). Saremo prevenuti o sbaglieremo, sicuramente, ma non possiamo esimerci dal notare due obiettivi fondamentali che ispirano l’azione del Ministero (dell’Istruzione). No, non si tratta di mettere al centro lo studente e di cercare di educarlo ‘integralmente’ affinché diventi un cittadino capace nell’azione e autonomo nel giudizio, destinato a realizzarsi e a realizzare la società intera. Certo, gli obiettivi sono anche questi, ma non sono quelli primari. Ciò che guida i passi del Ministero sono il desiderio di propaganda e la necessità di risparmiare. Allora da un lato si esaltano gli investimenti fatti e si promettono, in avvenire, investimenti faraonici; dall’altro si cerca di nascondere le ‘sforbiciate’ inflitte alla scuola non parlandone, negandole o facendole passare per progetti ben studiati, razionali, non dispersivi e sicuramente, in avvenire, efficaci. In fondo questa è l’epoca della Post-Verità mediatica. O no?