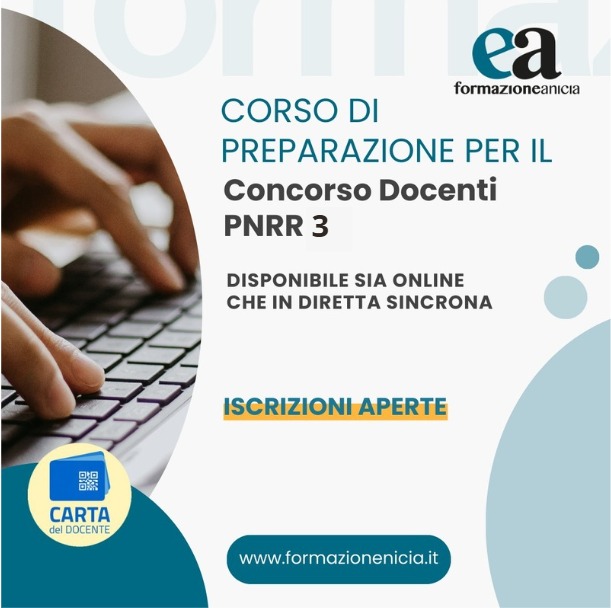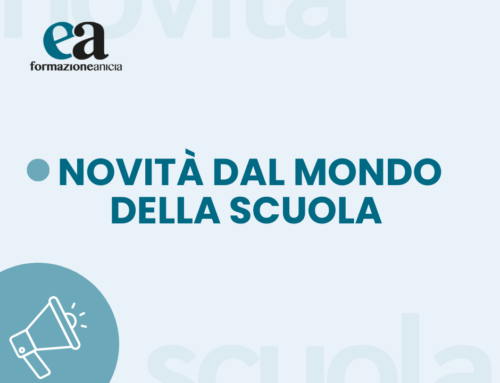Latino alle medie, un orpello ideologico dove ci vorrebbe più italiano
, il Sussidiario
Latino alle medie, un orpello ideologico dove ci vorrebbe più italiano.
La reintroduzione del latino è un progetto velleitario che misura la distanza abissale tra la scuola reale e quella ministeriale. La lettera
Caro direttore,
come ormai tutti sanno, dall’anno scolastico 2026-27, secondo le Nuove Indicazioni volute dal ministro Giuseppe Valditara, il latino tornerà nella scuola media: un’ora a settimana, come materia curricolare ma facoltativa per le famiglie. A questa novità si affiancano il ritorno al corsivo, la memorizzazione di poesie, la lettura della Bibbia come testo culturale e un programma di storia più centrato sull’Europa e sull’Occidente.
Tutto questo viene presentato come un ritorno alla “serietà” e, di conseguenza, come espressione del “merito”, al fine di porre un rimedio al presunto decadimento della scuola.
In realtà, la riforma introdotta sembra più una rievocazione nostalgica che un progetto educativo. La scuola vera, quella di tutti i giorni, è molto diversa da quella immaginata nei decreti. È fatta di classi affollate, di docenti che cambiano ogni anno, di laboratori chiusi, di computer vecchi, di palestre senza riscaldamento.
È la scuola dove gli insegnanti devono spiegare la differenza tra soggetto e complemento a tredicenni che leggono con fatica, dove si lotta per far amare un libro, dove la scrittura è spesso un terreno di smarrimento.
A questa scuola, che fatica a insegnare la lingua italiana, tuttavia, si risponde con un’ora facoltativa di latino. È come offrire una scultura antica a chi chiede un banco che non traballi.
I numeri parlano da soli. Le prove INVALSI 2025 ci dicono che solo il 60% degli studenti di terza media raggiunge il livello base in italiano: cinque punti in meno rispetto al 2019. Quasi 4 ragazzi su 10 non capiscono un testo di media difficoltà. E nel 2025 la situazione peggiora: calano ancora i punteggi medi in comprensione del testo.
Nelle superiori va anche peggio: nel biennio, senza scendere in dati tecnici, i risultati in italiano, in valori percentuali, sono inferiori rispetto a sei anni fa. Significa che un ragazzo su 3 non riesce a orientarsi in un testo scritto, non sa riassumerlo, non sa trarne un senso.
È questa la vera emergenza educativa del Paese. Eppure la risposta è il latino. Non più ore di lettura, non laboratori di scrittura, non classi meno affollate, ma un’ora di latino. Come se la radice di un problema fosse una mancanza di radici.
È la solita illusione: credere che un simbolo basti a cambiare la realtà. Le riforme parlano di “rigore” e “tradizione”, ma non ascoltano la scuola. Non ascoltano i docenti che si inventano esercizi per far leggere, né gli studenti che si sentono incapaci e finiscono per arrendersi. È facile parlare di “valori classici” da un ufficio ministeriale; è più difficile entrare in un’aula alle otto del mattino e cercare di spiegare perché la lingua serve a pensare, non solo a tradurre.
In questo contesto, le parole di Andrea Balbo, ordinario di letteratura latina nell’Università di Torino e coordinatore della sottocommissione per la stesura delle nuove linee guida del latino alle medie, suonano stonate. In un’intervista ha detto che “il latino è una lingua bella e inclusiva, che può collaborare con le altre materie e mettere in connessione culture e saperi”.
Bella e inclusiva. Ma per chi? Per ragazzi che non riescono a leggere un articolo di giornale, che zoppicano nello scrivere, che non capiscono le consegne di un compito? Non c’è nulla di inclusivo in una lingua morta proposta a chi non ha ancora imparato a “vivere” quella viva, come quella italiana.
Questa idea di scuola “alta” è in realtà profondamente distante dalla vita quotidiana degli studenti e, di riflesso, dalle loro famiglie. Non è un piano educativo, ma un manifesto politico. Il latino diventa un simbolo, un segno di appartenenza culturale da esibire, non uno strumento per capire meglio.
Si vuole far passare il messaggio che tornare indietro significhi andare avanti. Ma non è così. Una scuola che torna al passato senza risolvere i problemi del presente non recupera serietà: perde tempo. Il divario tra la scuola reale e la scuola dei decreti è abissale. La prima ha bisogno di insegnanti formati, di tempo, di spazi e di fiducia. La seconda si accontenta di parole altisonanti. Mentre si parla di “merito” e di “radici”, gli insegnanti correggono frasi senza punteggiatura, spiegano come si argomenta, come si legge, come si scrive.
Secondo il professor Balbo, il latino alle medie aiuterebbe i tredicenni attuali a capire meglio il legame culturale con la Cina. In una lettera pubblicata qualche giorno fa sul Corriere.it, il docente scrive: “quando alcuni testi base del confucianesimo cinese arrivarono in Europa, furono letti in traduzione latina per mezzo di opere come la Sapientia Sinica di Prospero Intorcetta del 1662 (che il Presidente Mattarella ha regalato al Presidente cinese in occasione dell’ultimo viaggio in Cina nel 2024) e il Confucius Sinarum Philosophus del 1687, letto da Leibniz e Voltaire. Che storia meravigliosa! Il latino per capire l’Oriente e non solo l’Occidente, per capire gli altri, oltre che noi”.
Mentre si celebra dunque il ritorno del latino, il lessico quotidiano dei ragazzi si restringe, le loro frasi si accorciano, la loro comprensione diminuisce. Il latino sarebbe una via impervia – ma facoltativa – per migliorare tutto questo.
Si dovrebbe piuttosto insistere sull’italiano in un’ottica di vera educazione linguistica. La riforma Gelmini, più di dieci anni fa, aveva già tolto ore di italiano. È stato allora che le competenze linguistiche hanno iniziato a calare, anno dopo anno. Quella ferita non è mai stata curata. Ora si prova a coprirla con la foglia di fico del latino, come se bastasse un tocco di classicità per sanare un sistema che non funziona. Ma non serve restaurare il passato: occorre costruire il futuro. La scuola non ha bisogno di simboli, ha bisogno di strumenti. Ha bisogno di più tempo per leggere, per discutere, per scrivere; di più ascolto, più cura, più fiducia (e di meno adempimenti).
Ha bisogno di restituire all’italiano – la lingua che ci unisce, che dà forma al pensiero, che permette di capire il mondo – la centralità che ha perso, in modo da “includere” le migliaia di stranieri che ripopolano le aule di scuola di un Paese in agonia per il calo demografico.
Introdurre il latino oggi alle medie, per come sono ridotte senza una riforma seria e profonda, è un gesto elegante, ma vuoto. È come lucidare un busto romano in un edificio che cade a pezzi. La scuola non chiede monumenti: chiede manutenzione. Non chiede un ritorno alle origini: chiede un futuro in cui le parole tornino a significare, a partire da quella della lingua di Dante e Manzoni, cioè la nostra.
Finché la politica continuerà a parlare di radici senza guardare le ferite, la distanza tra la scuola dei decreti e quella delle aule continuerà a crescere.
Il ministro Valditara ha affermato: “Se insegnare o meno il latino è una decisione che spetta al ministero, come ovunque nel mondo”. Giustissimo. Sarebbe anche bello chiedere ai docenti di lettere delle medie se il latino sia efficacemente utile ad analfabeti funzionali borderline.
P.S.: Caro direttore, un post scriptum per ogni evenienza. Lo scrivente non è contro il latino, al contrario. Di latino, e in generale di cultura classica, si è abbondantemente occupato in varie sedi e in molteplici forme ed è, da laureato in lettere antiche, cultore e docente.