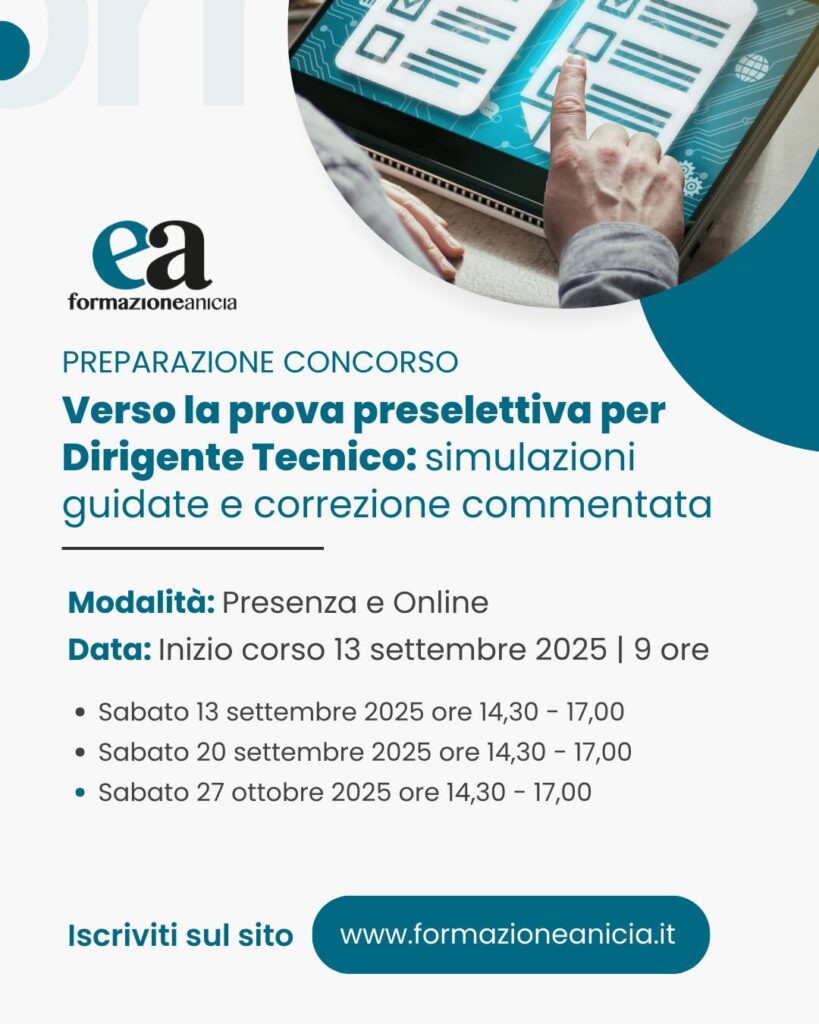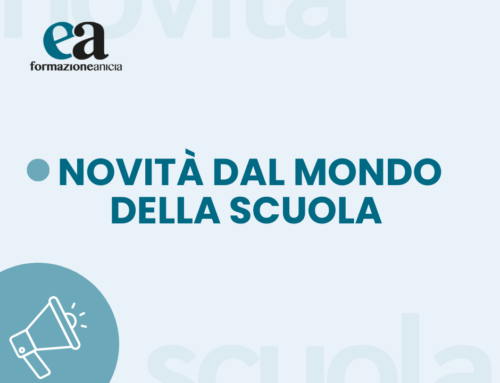Ritorno alle discipline, il coraggio di non indossare i “vestiti dell’Imperatore”
, il Sussidiario
Le nuove Indicazioni Nazionali del primo ciclo si pongono l’obiettivo di favorire una rinnovata attenzione alle singole discipline di insegnamento.
Per concessione dell’editore, anticipiamo un estratto dell’editoriale del numero di settembre di “Nuova Secondaria” (ndr)
A distanza di oltre un decennio dalle precedenti, le nuove Indicazioni Nazionali per le scuole del primo ciclo si pongono l’obiettivo di favorire, nel rispetto dell’autonomia delle singole istituzioni scolastiche e delle scelte didattico-professionali degli insegnanti, da un lato un rilancio dell’alleanza scuola-famiglia; dall’altro una rinnovata attenzione sulle conoscenze fondamentali relative alle singole discipline di insegnamento.
Sotto il primo profilo appare sempre più chiaro che nessuno può “salvarsi da solo” né crescere e maturare i propri talenti personali senza la collaborazione di tutti gli attori coinvolti nell’avventura educativa, insegnanti e genitori in primis.
Sotto la seconda dimensione, le nuove Indicazioni Nazionali, provando a contrastare ulteriori cali dei livelli degli apprendimenti nelle future generazioni, rimettono al centro dei processi di insegnamento/apprendimento il ruolo delle conoscenze disciplinari nel percorso di studio degli studenti fin dal primo ciclo.
Non un ritorno ad un nostalgico “nozionismo”, quanto piuttosto una volontà di restituire centralità e importanza a quei saperi fondamentali, significativi e culturalmente di valore, senza i quali ogni ulteriore sviluppo di competenze (comprese quelle “socio-emotive”) risulterebbe nei fatti compromesso.
Si tratta, insomma, di voler superare una facile quanto fallace narrazione che vedrebbe una contrapposizione tra conoscenze e competenze, tra discipline e dimensione personale. Compito dell’istituzione scolastica è di sviluppare la persona di ogni studente attraverso le discipline di studio, riscoprendo così il valore e la passione per la conoscenza.
È quanto ha sostenuto in un volume, recentemente pubblicato nell’edizione italiana – La riscoperta dei contenuti. Educare alla saggezza nelle scuole d’America (Studium, 2025) – David Steiner, direttore dell’Institute for Education Policy presso la Johns Hopkins University di Baltimora (USA). La tesi del testo dell’esperto statunitense è tanto semplice quanto diretta: “cercare di insegnare competenze cognitive in assenza di conoscenze vere e proprie è un sicuro passaporto verso l’ignoranza. L’invitante proposta a intraprendere questa strada potrebbe sembrare come miele, invece, è puro veleno per l’educazione” (p. 141).
La sua affermazione nasce nel contesto americano dove, a furia di inseguire alcune grandi tendenze degli ultimi decenni in ambito educativo come l’apprendimento socio-emotivo, il pensiero critico e creativo e la mentalità di crescita (growth mindset) il sistema d’istruzione corre il rischio di smarrire il proprio compito.
Paradossalmente, proprio nell’epoca dell’ipertrofia informativa nella quale grazie all’Intelligenza Artificiale la conoscenza sembra come non mai a portata di mano, un richiamo ai saperi fondamentali, alle conoscenze significative e ai contenuti delle singole discipline appare cruciale.
Altrimenti saremo condannati, come nella fiaba di Hans Christian Andersen I vestiti nuovi dell’imperatore (1837), a ripetere in coro che va tutto bene per paura di non apparire retrogradi, passatisti o reazionari dinanzi a una pletora di sudditi compiacenti che accetta la rinuncia alla valutazione critica per non turbare e non essere turbati.
Finché non verrà la voce di un fanciullo a gridare a tutti la verità, svelando che “il re è nudo”, smascherando le ipocrisie diffuse, i vuoti pedagogici e le mode pseudo-progressiste, che sostituiscono la conoscenza e la competenza con l’opinione e l’impegno con la visibilità.
Occorre allora riscoprire il coraggio civile e intellettuale di riconoscere che non tutto ciò che brilla è oro, il coraggio di rifiutare le scorciatoie rassicuranti, il coraggio di formare cittadini liberi e non individui accondiscendenti, che si rifugiano nell’anticonformismo proprio per meglio conformarsi.
Ritornare ai saperi fondamentali, soprattutto nel primo ciclo, rappresenta una condizione necessaria per provare a rispondere alla situazione di progressivo, generalizzato declino negli apprendimenti e nelle competenze degli studenti, affrontando il problema con coraggio e senza infingimenti né inutili indulgenze.
Si tratta, in altre parole, di recuperare quella tradizione pedagogica che è in grado di valorizzare il mezzo delle discipline di studio per il fine della persona in quanto tale. Lo ha sottolineato Evelina Scaglia in un recente studio dedicato al maestro Alfredo Giunti (1920-1993) laddove scrive: “dal rispetto dell’intima natura di ogni disciplina passava, con più facilità, il rispetto della natura profonda dell’allievo, e viceversa”, perseguendo così quell’“accordo armonico fra le istanze psicologiche dell’allievo e le istanze logiche della disciplina di studio”. In questo superando affrettati riduzionismi in uno o nell’altro senso, nonché una falsa contrapposizione tra conoscenze e competenze.
In questo percorso, infine, occorrerebbe sempre aver presente quanto troviamo scritto nel recente volume Governare la fragilità di Roberto Garofoli e Bernardo Giorgio Mattarella, nel capitolo dedicato alla scuola, dove si legge un’affermazione tanto semplice quanto dirompente: “l’istruzione fa bene non solo al singolo, ma anche alla società” (p. 239). Riconquistare questa consapevolezza diffusa sarebbe già un primo passo importante per affrontare le sfide e i problemi del sistema d’istruzione e formazione di oggi e di domani.