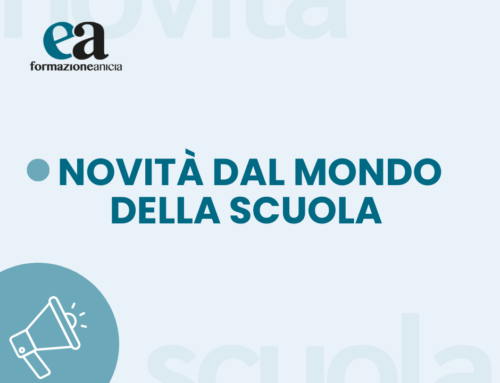Pseudo-oggettività a scuola: un progetto totalitario
di Sagredo, il Gessetto
Pedagogia e docimologia aspirano a una scientificità impossibile perché i loro scopi non detti sono rivoluzionari, eversivi: e infatti descrivono il sistema scolastico che stanno distruggendo come marcio, reazionario, anti-democratico.
L’intellettuale, storico della scienza, epistemologo e matematico Giorgio Israel (1945-2015) ha colto l’essenza di molti cambiamenti peggiorativi nella scuola italiana (e non solo). Nell’illuminante saggio Chi sono i nemici della scienza, il processo di imbarbarimento della scuola promosso attraverso tesi bislacche e pericolose, viene ricondotto a un più generale smarrimento della cultura nel nostro paese attraverso un’analisi argomentata, accurata e spietata. Nondimeno il male che affligge la scuola ha peculiarità proprie. Leggiamo.
***
Ma è chiaro che la posizione di preminenza della docimologia (e della pedagogia) non si afferma sul piano scientifico, bensì su quello politico, e questo è proprio quel che è accaduto nei fatti. Si è creata una casta di intoccabili, come risultato di un progetto lucidamente perseguito. Sebbene l’idea della pedagogia, della didattica e della docimologia come scienze oggettive, sul modello fisico-matematico, risalga ai primi decenni del ‘900, essa ha preso forza in numerosi paesi europei – e segnatamente in Italia – entro un progetto fortemente contrassegnato da una volontà rivoluzionaria e di scardinamento (questi termini vengono frequentemente usati) di un sistema della ricerca e dell’istruzione considerato e definito come un’eredità ottocentesca e reazionaria. Il «pedagogismo democratico» o «progressista» è una sintesi fra il progetto scientista di cui si diceva e le tendenze rivoluzionarie emerse nel ’68. L’obbiettivo è quello di abbattere la «scuola di classe» con il maglio dell’oggettività della valutazione e delle dottrine pedagogiche: renderle egemoni nell’istruzione è l’unico modo per demolire il bastione della «vecchia» scuola, e cioè la cultura tradizionale degli insegnanti. Uno dei mezzi per realizzare questa egemonia è quello di sostituire all’idea di «interdisciplinarietà» quella di «iperdisciplinarietà»: anziché far interagire le discipline occorre dissolverle all’interno di un contesto unitario. Strumento fondamentale di tale operazione sarebbero la multimedialità e il calcolatore. Si è parlato esplicitamente di questo approccio come di un «grimaldello» capace di «scardinare i saperi formativi tradizionali»1 e addirittura della sua funzione «velenosa», in un senso ritenuto buono, s’intende.
In tal modo si realizzerebbe l’obbiettivo «sessantottino» di distruggere la «scuola di classe» – che favorisce i già privilegiati mantenendo i loro vantaggi e non fa progredire gli svantaggiati lasciandoli nella loro condizione subordinata e costruire la condizione ideale in tutte le teorie di derivazione più o meno consapevolmente marxista: l’egualitarismo.
E che cosa di più dell’oggettivismo – oggettività nella definizione dei contenuti dell’insegnamento e, soprattutto, nella valutazione – può garantire meglio la realizzazione dell’egualitarismo?
Come ha detto ripetutamente Tullio De Mauro – anche nella sua veste di Ministro della Pubblica Istruzione – scopo della scuola è di non lasciare nessuno indietro e di far sì che tutti raggiungano lo stesso livello. Per ottenere tutto ciò occorrono dei garanti, rappresentanti e ministri dell’oggettività e costoro sono i pedagogisti e i docimologi progressisti, muniti delle loro teorie «oggettive». Ponendosi a supremi garanti del sistema della formazione culturale nel suo complesso essi diventano una casta di intoccabili, il riferimento supremo, che non può essere contestato e sottoposto a giudizio senza mettere in discussione l’intera costruzione.
Questa casta ha ottenuto una posizione di potere e di impunità per due vie: una teorica e una pratica. Quella pratica è consistita nell’insediarsi abilmente in tutti i centri nevralgici di controllo del sistema dell’istruzione e della valutazione. Ciò è accaduto in Italia, ma anche in altri paesi come la Francia. È indicativo di questo stato di cose la vicenda di un matematico di prestigio come Lafforgue, costretto a dimettersi da una commissione ministeriale per aver osato denunciare le «politiche ispirate da un’ideologia che non attribuisce valore al sapere, bensì «a teorie pedagogiche deliranti» alla «teoria dell’allievo al centro del sistema e che deve costruire lui stesso i suoi saperi». La seconda via è stata quella teorica, consistente nel nascondere le elucubrazioni pedagogiste dietro il paravento della necessità di una sorta di metadisciplina di «garanzia», quella appunto preposta a integrare tutte le altre, a garantire la loro coerenza e quindi, in definitiva, a stendere le regole del sistema dell’istruzione e della valutazione.
Si tratta di un paravento che è meno di una foglia di fico e che ha retto soltanto perché sono stati in pochi ad avere tempo e voglia di mettere sotto i riflettori le miserie della disciplina. La lettura di certi testi dovrebbe portare all’esclusione in perpetuo dai finanziamenti della ricerca coloro che li hanno prodotti. Uno degli esempi più grotteschi di queste miserie pseudoscientifiche è dato dall’ossessivo ricorso alla distribuzione normale o gaussiana. Talora si cita la cosiddetta «legge di Posthumus» secondo cui «un docente tende a aggiustare il livello del suo insegnamento e le sue valutazioni sulle prestazioni degli allievi in modo da conservare di anno in anno, approssimativamente, la stessa distribuzione gaussiana dei voti»: e la si cita per dimostrare che la valutazione soggettiva o normativa conduce a risultati fuorvianti. Altrove si osserva che
nelle scienze umane, la curva a campana di Gauss ha una considerevole funzione, perché essa è l’immagine stessa della ripartizione di molte attitudini e qualità: gli individui medi abbondano, ma i geni e gli idioti, i giganti e i nani sono rari. La curva di Gauss è sia il riflesso della legge del caso che presiede alla nostra nascita, sia la ri-sultante dell’influenza di un gran numero di fattori che agiscono in maniera più o meno indipendente su di un individuo o un oggetto.
E si spara questa tesi a dir poco azzardata per ricavarne una conclusione ancor più arbitraria, e cioè che «il mastery learning ha dimostrato l’esatta corrispondenza tra la rappresentazione grafica, in forma di curva gaussiana, che si ha quando gli studenti sono normalmente distribuiti riguardo all’attitudine e la medesima rappresentazione dei loro risultati al completamento del ciclo di istruzione se a essi fosse fornita un’istruzione uniforme in termini di qualità e di tempo». Difatti, la gaussiana, prima utile a criticare la valutazione tradizionale, ora diventa fondamento di quella «oggettiva».
E il bello è che ciò viene fatto in pratica, usando tale criterio per valutare se la valutazione è stata fatta in modo corretto: se essa non corrisponde alla gaussiana vuol dire che è stata fatta male. Ma la distribuzione normale ha senso rispetto alla misurazione di un numero elevatissimo di eventi indipendenti. Pertanto far uso di questa nozione nel contesto di insiemi limitati di studenti e addirittura di una classe – in cui non sono soddisfatti né il requisito dei «grandi numeri» né quello dell’indipendenza è la più straordinaria cialtronata che si possa immaginare.
Inoltre, il ricorso alla distribuzione normale viene usato in funzione di appiattimento, ovvero per tagliar fuori le punte estreme (somari e primi della classe) come anomalie rispetto alle capacità medie acquisite in una istruzione «uniforme» il che è aberrante perché è proprio in queste situazioni estreme che possono annidarsi i casi più interessanti. Il risultato è il livellamento verso il basso, verso la media minima“, secondo la definizione sgangherata di Tullio De Mauro”. È l’ideologia di un egualitarismo triste e cupo, di stampo sovietico.
Risparmiamoci altre amenità, come i tentativi di valutazione quantitativa della creatività e addirittura di definire un’unità di misura della creatività; o certe deliranti disquisizioni sulla «misurazione della cultura». Dopo decenni di pedagogismo «scientifico» e di docimologia è ormai insostenibile la pretesa che soltanto queste discipline, in quanto metadiscipline, siano esenti dalla valutazione – diciamo pure da un giudizio – cui invece sono soggette le discipline «ordinarie» come la fisica, la matematica, la biologia o la filologia classica. Ma non è soltanto sul piano teorico, bensì anche su quello pratico che esse debbono subire l’esame. Difatti, chi ha avuto l’opportunità di esercitare la propria influenza, anzi di comandare e sperimentare in corpore vili e con ogni mezzo le proprie teorie non può esimersi dal rendere conto dei risultati. E i risultati sono quelli che sono: una catastrofe clamorosamente evidente.
Per questo motivo i pedagogisti e i docimologi progressisti oggi camminano lungo i muri cercando di evitare che l’attenzione si concentri su di loro, nella speranza che passi la tempesta, anche se non mancano però, in tutte le situazioni in cui i loro agganci con la politica lo consentono, di difendere accanitamente le loro posizioni. Il caso di Laurent Lafforgue ne costituisce l’esempio più clamoroso. Giustamente egli ha osservato che «tutte queste persone hanno oggi uno scopo soltanto: scaricare le loro responsabilità e quindi mascherare con tutti i mezzi la realtà del disastro».
Resta da fare qualche osservazione sul movente profondo che sta dietro questa ossessione di sottoporre la cultura, la scienza e l’istruzione a una misurazione quantitativa oggettiva e a processi di standardizzazione. Si tratta di una profonda sfiducia nell’uomo, una sfiducia tanto radicale da spingere a inventare qualsiasi marchingegno pur di eliminare la sua visibilità, le sue tracce e persino il sospetto della sua presenza. Così facendo si elimina anche la creatività delle persone.
Come stupirsi allora dello stato di profonda umiliazione, abbattimento e depressione in cui cadono tutte le persone soggette alle procedure di standardizzazione?
Il docente della scuola standardizzata secondo i metodi di tipo docimologico-didattichese non è più un uomo di cultura che, sia pure entro certe finalità, programmi e metodologie, trasmette le sue conoscenze e la sua esperienza per formare persone, ma un «operatore», un funzionario scolastico, un burocrate dell’istruzione che è tanto più apprezzato quanto più cancella la sua soggettività – il che, in definitiva, è impossibile, e provoca soltanto le conseguenze disastrose che abbiamo sotto gli occhi. Non vi è da stupirsi per questi esiti umilianti, visto che l’ideologia dominante è che il docente non debba insegnare e tanto meno educare, ma debba limitarsi esclusivamente a coadiuvare l’alunno in un processo di apprendimento autonomo.
Insomma, il docente non è più un insegnante e un educatore, ma soltanto un animatore culturale, una figura del tutto analoga a quegli «animatori» delle feste di compleanno dei bambini che facilitano la socializzazione e il divertimento proponendo giochi e guidando la festa nel modo più gradevole possibile.
Qui si tratta soltanto di socializzare il processo dell’apprendimento. È un esito davvero bizzarro sopprimere la soggettività del docente per esaltare quella dell’allievo secondo i criteri sciatti e servili del più squallido giovanilismo!
In tal modo, l’incontro tra due persone viene trasformato nel servizio prestato da un impiegato a un giovane utente che gode di ogni diritto e non è soggetto ad alcun dovere. Riconosciamo in questa visione le caratteristiche tipiche di una visione totalitaria, che cerca di sopprimere il ruolo della soggettività e conformare tutto a una dottrina imposta dall’alto. L’aspetto più deprimente di questa faccenda è che l’influsso di queste visioni è stato tale da imporsi anche a chi si richiamava a concezioni opposte, di tipo liberale, e mirava persino a combattere il carattere statale del sistema dell’istruzione e della ricerca; non avvedendosi che anche un sistema privatistico basato su tali criteri oggettivisti – intrinsecamente egualitari – sarebbe un sistema totalitario.
Ancor più deprimente è che si siano assoggettati a tale visione persone che credono nel merito e nella necessità di premiarlo, mentre la scuola del pedagogismo progressista ha appiattito tutto verso il basso, facendo dell’ultimo della classe il riferimento del sistema. Al contrario, la «vecchia» scuola assumeva come punto di riferimento il livello più alto e non congelava affatto i ruoli, bensì offriva le opportunità e gli stimoli ad andare verso traguardi più elevati. Come abbiamo già osservato, l’egualitarismo del pedagogismo «democratico» è riuscito a realizzare proprio quella scuola di classe che si proponeva pomposamente di combattere.
Concludiamo osservando che una delle tendenze centrali del pedagogismo progressista è lo spostamento dell’attenzione dai contenuti dell’istruzione al metodo: ancora una volta l’approccio dei nullatenenti. È lo spostamento dal tema del «sapere» a quello del «saper fare» o del «saper essere», con la conseguente costituzione di un insieme di metodologie, di approcci, di regole che non soltanto relegano la figura del docente a quella di mero esecutore e la umiliano nelle forme già descritte, ma si configurano come un’ideologia totalitaria e autoritaria, concretamente impersonata da una corporazione strapotente in ambito politico e amministrativo.
È la teoria secondo cui occorre passare dalla cultura delle discipline alla cultura delle competenze, e che si propone per tale via di scardinare l’intera cultura degli insegnanti. Gli insegnanti dovrebbero vedere messa in discussione la loro cultura da personaggi che non hanno mai visto una disciplina nella loro concretezza, visto che non si vergognano di contrapporre discipline a competenze, e addirittura di parlare di competenze come incarnazione delle conoscenze, come se fosse possibile considerare le tecniche del calcolo infinitesimale o delle equazioni algebriche come un’«incarnazione» di conoscenze che vivrebbero in un mondo di astrazioni.
Ed è ora chiaro se ripensiamo a quanto visto in precedenza – che è proprio su tali basi deliranti che è stato ripensato l’insegnamento della matematica.
Può un paese avanzato mettere il sistema dell’istruzione in simili mani?
NOTE
- Si veda G. Stelli, Il filo di Arianna. Relativismi post-moderni e verità della ragione, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Napoli, 2007.[tratto da: Giorgio Israel, Chi sono i nemici della scienza? Riflessioni su un disastro educativo e culturale e documenti di malascienza, Lindau, Torino, 2008, pp. 58-62]