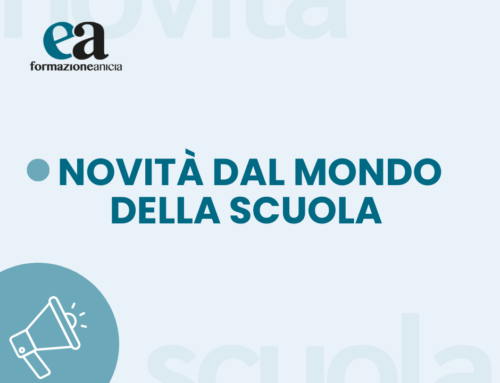Riforma, deforma, e l’esame più non torna
Ancora sul boicottaggio della prova orale dell’esame di Stato… con una sorpresa finale.
di Dario Roman, il Gessetto
I fatti
All’esame di Stato tre studentesse di un liceo di Venezia, venute a conoscenza della valutazione degli scritti, contestano la votazione della versione di greco ritenendola eccessivamente severa (pochissime sufficienze in tutta la classe). Così, per protesta, si rifiutano di svolgere la prova orale. Al colloquio si presentano senza aprir bocca, ma una di loro dichiara: “questo non è il nostro fallimento, ma il vostro”. La notizia fa il giro della penisola. Si scatenano i giornalisti, le pose coi fiori, le foto, i fotografi; le tre accettano di farsi intervistare e affermano: “l’esame non rispecchia quella che è la valutazione del nostro curriculum, della nostra storia; siamo contente di essere riuscite ad attirare l’attenzione su di noi”. L’opinione pubblica inizia a polarizzarsi, com’è prevedibile: chi è perplesso su valutazioni dello scritto così negative, chi si chiede come può l’istituzione permettere un comportamento disobbediente di tal fatta. Il ministero, mantenendosi in una zona neutrale, si limita a far accertare la regolarità delle procedure mediante l’invio degli ispettori al liceo e tutto risulta regolare.
L’analisi
L’episodio, anche se ripulito della strumentalizzazione che ha subito, costituisce tuttavia un indicatore interessante di quella che è la percezione delle cose nel tempo presente. Il sentirsi indignate per una valutazione ritenuta ingiusta mostra che le tre studentesse, a torto o a ragione, presumono di saper valutare meglio dei docenti e della commissione d’esame. Non è chi sa di più che giudica chi sa di meno, ma chi sa di meno che scavalca e giudica chi sa di più. Alla radice, vediamo essenzialmente la scomparsa del principio di autorità: laddove l’autorità, le istituzioni e i principi non vengono più riconosciuti come tali, ognuno si sente in diritto di erigere il suo personalissimo punto di vista a legge di giustizia assoluta. “Questo non è il nostro fallimento, ma il vostro” equivale a dire “non siamo noi studentesse ad aver fallito ma voi professori, voi scuola, voi istituzione; e noi adesso ci permettiamo di giudicare voi, perché ciò che avete fatto non ci piace”. La cosa si commenta da sé: confusione sui ruoli e traslazione delle rispettive responsabilità.
C’è poi un altro tipo di confusione, non meno pernicioso, sulla natura dell’esame. “L’esame non rispecchia la valutazione di quello che siamo veramente, del nostro curriculum e delle valutazioni che abbiamo sempre preso in greco durante l’anno”, hanno dichiarato le tre candidate. Ma l’esame non deve rispecchiare la valutazione di “quello che è veramente” il candidato, né tantomeno del percorso che ha già fatto. L’esame è un esame e basta: deve rispecchiare quello che il candidato dimostra di sapere nelle prove d’esame. Molti di noi sono consapevoli di aver fatto anche male l’esame, a suo tempo, e di aver preso un punteggio più basso di quello che potevamo prendere (e meritare); ma nessuno si è mai sognato di protestare (tantomeno con la disobbedienza civile) nei confronti dell’esito, perché sapevamo appunto che l’esame è un esame.
Dunque in gioco non c’è solo la tutela del rapporto necessariamente asimmetrico tra docente e allievo, tra chi sa di più e chi sa di meno, ma anche della vera natura dell’esame: oggi studenti, genitori, ma anche docenti e buona parte dell’opinione pubblica, ritengono che l’esame di Stato (di maturità!) debba rispecchiare quello che è il valore autentico dello studente, valore desumibile dal percorso scolastico dello studente o per così dire autocertificabile dallo studente stesso. Constatata l’inutilità di un esame del genere, che convalidi e confermi il valore dello studente, tanto varrebbe eliminarlo: e una parte delle forze politiche sta in effetti cavalcando da tempo questa idea. Con ciò però, oltre a cancellare il valore legale del titolo di studio, si disintegrerebbe quella naturale e formativa tensione pedagogica che porta gli studenti a misurarsi con le prove della vita.
L’alternativa è quella di recuperare l’antica e corretta idea di esame, come procedura finalizzata ad acquisire informazioni sull’autentico livello di conoscenze e di competenze dei candidati. Per farlo è necessaria una doppia operazione: da una parte rendere l’esame più serio, dall’altra modificare nuovamente la percezione che la gente ne ha. L’attuale esame di Stato è un compromesso, poiché tiene conto sia del curriculum dello studente mediante il sistema dei crediti, sia della sua prestazione in due prove scritte e un colloquio interdisciplinare. Ora, a ben vedere è questa struttura stessa che ha contribuito a generare l’attuale percezione di che cosa debba essere un esame per essere ritenuto giusto e legittimo. Non è difficile da comprendere: ben il 40% del punteggio dipende dal curriculum dello studente (quindi quasi metà dell’esame è già fatto prima di cominciarlo), poi c’è un 20% della prova d’italiano, un altro 20% della seconda prova d’indirizzo, e un altro 20% del colloquio interdisciplinare. Insomma le continue riforme dell’esame hanno portato ad avere un esame che a sua volta ha modificato l’idea di che cosa debba essere l’esame… e di conseguenza ha reso l’esame in sé quasi inutile.
Ma la strada per una riforma seria (e meritocratica) dell’esame di Stato – e della scuola – è ancora aperta e possibile. E se si dovesse riformare in tal senso l’esame, ritornerebbe a modificarsi nuovamente l’idea di che cosa esso debba essere. L’esame ritornerebbe ad essere un esame vero, a creare un legittimo timore negli studenti, ad avere dei bocciati, così come ritornerebbe ad essere un deterrente nei confronti di tutti coloro che volessero disobbedirgli in qualche modo.
E infine: “siamo contente di essere riuscite ad attirare l’attenzione”. È una frase emblematica dello spirito dei tempi, laddove ognuno gode se riesce a mettersi egocentricamente e narcisisticamente in mostra allo scopo di attirare l’opinione pubblica su una posizione del tutto personale e soggettiva. E così facendo eleva il suo soggettivo punto di vista a una forza legittimante – quella dell’opinione pubblica, amplificata dai media – che nulla ha a che fare con la verità delle cose e con la giustezza dei principî. Simili azioni, che non di rado vengono elogiate dagli adulti come manifestazioni di maturità e consapevolezza nei ragazzi, hanno in realtà un risvolto antieducativo: i giovani, come i popoli, hanno anche bisogno di riferimenti, e questi per essere tali debbono essere super-partes, non sub-partes, come accade nelle posizioni personalistiche, individualistiche e soggettivistiche. Noi intellettuali abbiamo il dovere di mettere in guardia da questi condizionamenti e dal pericoloso e manipolatorio gioco dell’opinione pubblica.
–––––––
Ai lettori più attenti non sarà sfuggito un particolare all’inizio di questo articolo: il riferimento a tre studentesse di un liceo classico di Venezia. Qualcosa non torna, vero? Sì, perché l’episodio narrato riguardava l’esame di stato del 2024. E il testo di analisi fu scritto nel luglio dell’anno scorso. Ma i precedenti inducono alla ripetizione degli atti: com’era prevedibile, quest’anno si sono ripetuti e sono aumentati di numero i casi di studenti che hanno deciso di ‘saltare’ il colloquio orale. Tutti studenti che, punteggi alla mano, hanno visto che potevano farlo senza rimetterci la promozione. E che continuano a farlo legittimando la loro scelta con motivazioni se possibile ancora più irricevibili di quelle delle tre studentesse veneziane del 2024: “non sono stata capìta”, “non hanno voluto conoscere la mia vera persona”, “mi hanno umiliato” e così via. A questo punto ci si chiede con terrore quali saranno le motivazioni l’anno prossimo. Ma gli esami non sono forse l’anticamera delle prove della vita? Un addestramento in tal senso? E in tal guisa non hanno quindi un valore educativo e formativo? È veramente il momento di fare qualcosa.
Ripristiniamo un esame serio: ripristiniamo un esame. Ma attenzione: non sarà sufficiente, come il ministro ha annunciato, minacciare di bocciatura coloro che si rifiutano di sostenere il colloquio.
Bisogna restituire serietà a tutto l’esame, che oramai da troppo tempo è stato delegittimato.
Crediti scolastici che pesano troppo sul punteggio finale; prova orale non seria e non meritocratica, a partire dal nome di ‘colloquio’; valutazioni di prove ed esperienze personali che poco hanno a che fare con il senso di un qualsiasi esame: tutto questo deve essere sostanzialmente modificato.
Certo, se l’intenzione del ministero è – giustamente – quella di restituire dignità alla professione docente, per ottenere questo sarà necessario restituire serietà non soltanto all’esame ma a tutta la scuola, e quindi al ruolo dei docenti e alle condizioni in cui lavorano. Un lavoro enorme è da fare. Ma bisogna cominciare, e finalmente senza compromessi.
.